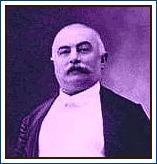La musica esercita un'azione profonda sulla psiche umana: alcune volte suscitatrice di grandi gioie, altre volte di una voluttuosa felicità, altre volte ci trasporta come in un sogno. evocatore di sentimenti e d'idee piacevoli, talvolta tristi oppure penose; spesso produce stati emotivi che affiorano inconsciamente e trasportano fino all'estasi. Potere occulto indescrivibile, direi magico, che nasce dalle facoltà inventive del compositore, il quale attinge nei piani più alti dell'essere e si trasmette negli ascoltatori attraverso gli strumenti, in base a leggi naturali e ritmiche occulte finora non completamente conosciute.
La musica esercita un'azione profonda sulla psiche umana: alcune volte suscitatrice di grandi gioie, altre volte di una voluttuosa felicità, altre volte ci trasporta come in un sogno. evocatore di sentimenti e d'idee piacevoli, talvolta tristi oppure penose; spesso produce stati emotivi che affiorano inconsciamente e trasportano fino all'estasi. Potere occulto indescrivibile, direi magico, che nasce dalle facoltà inventive del compositore, il quale attinge nei piani più alti dell'essere e si trasmette negli ascoltatori attraverso gli strumenti, in base a leggi naturali e ritmiche occulte finora non completamente conosciute.
La musica, con le sue notazioni, l’idea musicale, il motivo, è così sentita nei piani superiori dell'essere umano, che Beethoven, già privo dell'udito, componeva le sue Sinfonie senza sentirne il suono e quindi senza poter percepire gli effetti che esse potevano suscitare, tanto che, volgendo lo sguardo verso i suoi ascoltatori, si stupiva vedendoli in lacrime di commozione, meravigliato che la sua musica avesse potuto raggiungere le intime latèbre dei cuori attraverso l'udito, l'organo che in lui da tempo era immoto e reso inutile per la fantasia e per il sentimento.
Il fascino insensibile ed occulto della musica trae origine, oltre che dall'unione dei suoni con le idee, con i sentimenti, con la fantasia ecc. dall'effetto fisiologico che risente il sistema nervoso quando con ripetizione ritmica e lenta viene accarezzato, stancato o eccitato un organo importante quale è l'udito. Si può trovare forse la ragione del senso di pace che molte anime acquistano ascoltando una sonata del Paradiso, ovvero i primi due tempi soavi della VI Sinfonia di Beethoven (la Pastorale) in cui è riflessa la serena dolcezza agreste della natura. Così pure deve pensarsi che i Canti per arpa di David dovessero contenere un ritmo dolce che serviva a rabbonire l'animo irritato di Saul. Forse erano composti di note a ritmo uguale e cadenzato, agenti quali diapason vibranti ad intervalli uguali.
Paradiso, ovvero i primi due tempi soavi della VI Sinfonia di Beethoven (la Pastorale) in cui è riflessa la serena dolcezza agreste della natura. Così pure deve pensarsi che i Canti per arpa di David dovessero contenere un ritmo dolce che serviva a rabbonire l'animo irritato di Saul. Forse erano composti di note a ritmo uguale e cadenzato, agenti quali diapason vibranti ad intervalli uguali.
È noto a tutti gli ipnotisti empirici che una impressione sonora dello stesso tono monotono, come per esempio quello del diapason, determina il sonno in alcuni individui sensibili: lo stesso può succedere ad altri che ascoltano il tic-tac di un orologio. Questo stato che si chiama fascinazione, non è uno stato ipnotico propriamente detto, ma una specie di suggestione allo stato di veglia che ha di comune con l'ipnotizzato l'abolizione della volontà. e l'automatismo.
La musica è anche un mezzo per eccitare il coma magnetico. È raro che l'uomo non ne senta l'influenza. Essa, se sentita, lo pone in uno stato di automatismo momentaneo e passeggero. Ciò era conosciuto anche dagli antichi, i quali la consideravano non soltanto come un sollievo benefico della mente, ma vi attribuivano qualità medicinali e curative. Pindaro afferma che Esculapio curava delle malattie per mezzo di canzoni molli, graziose, voluttuose, oppure, secondo altri interpreti, con dolci incantesimi.
Empedocle, poeta e filosofo di Agrigento, chiamò la musica in soccorso della filosofia e per guarire le passioni; per le guarigioni ottenute fu considerato mago.
Alle melodie dei Bramini, chiamate Ragas, conservate per tradizione, si attribuivano virtù particolari di ammansire le belve, di incenerire chi le avesse cantate, di far cadere la pioggia, di fare oscurare il sole. Il testo di alcune di queste è conservato nei libri dei Veda.
Orfeo, come narrato nella mitologia greca, adoperava una cetra donatagli da Mercurio o da Apollo alla quale egli aggiunse due corde alle sette che già aveva quello strumento. Egli ne traeva suoni armoniosi e nell'accompagnare la propria voce allietava finanche le cose insensibili. A quelle soavi melodie le belve più feroci accorrevano e vi erano attratti financo gli uccelli. Al suono della sua lira, racconta il mito, i venti tacevano, i fiumi arrestavano il loro corso, gli alberi danzavano. Con la sua mirabile arte lirica riuscì ad addolcire i costumi dei Traci di quel tempo, riducendoli da una vita selvaggia alle dolcezze di una società civile. Narra anche il mito che Anfione, figlio di Giove e di Antiope, costruì le mura di Tebe al suono della sua lira: le pietre andavano da se stesse a porsi le une sulle altre.
La musica faceva parte dello studio degli antichi pitagorici e Pitagora introdusse la musica nella terapeutica; i pitagorici ne facevano uso per incitare gli adepti ad atti lodevoli e per infiammarli all'amore della virtù. Secondo i pitagorici l'anima nostra è formata di armonia e quindi, per mezzo della musica, essi facevano rivivere la primitiva armonia delle facoltà dell' anima, quell'armonia che esisteva prima che essa animasse i nostri corpi quando era abitatrice del Cielo.
terapeutica; i pitagorici ne facevano uso per incitare gli adepti ad atti lodevoli e per infiammarli all'amore della virtù. Secondo i pitagorici l'anima nostra è formata di armonia e quindi, per mezzo della musica, essi facevano rivivere la primitiva armonia delle facoltà dell' anima, quell'armonia che esisteva prima che essa animasse i nostri corpi quando era abitatrice del Cielo.
Il Mondo è armonia; le parti celesti dell'universo sono tra loro connesse in un equilibrio superiore da cui nasce un'armonia ideale, sublime, che nessun udito umano è in grado di percepire. Così la musica appare quale un prodotto della simpatia e dell'accordo di tutte le cose, che è risonanza dell'ordinamento universale. Ed è da osservare che la teoria pitagorica dell'armonia delle sfere è stata amalgamata dalla Chiesa, la quale è riuscita a stabilire una relazione fra l'antica metafisica musicale e le affermazioni delle sacre scritture comprovanti le origini divine della musica.
Presso gli antichi la musica faceva parte dell'educazione. Platone, prescrivendo il modo con cui dovevasi educare i fanciulli nella repubblica, ordinava, fra l'altro, l'applicazione della musica per lo spazio di tre anni.
 Secondo Polibio, la musica era necessaria per addolcire i costumi degli Arcadi i quali abitavano un paese ove l'aria era fredda e grave; mentre quelli di Cineto, avendo trascurata la musica, superarono in crudeltà tutti i greci, al punto che non vi era altro luogo ove si fossero commessi tanti delitti.
Secondo Polibio, la musica era necessaria per addolcire i costumi degli Arcadi i quali abitavano un paese ove l'aria era fredda e grave; mentre quelli di Cineto, avendo trascurata la musica, superarono in crudeltà tutti i greci, al punto che non vi era altro luogo ove si fossero commessi tanti delitti.
Dobbiamo studi profondi sulla musica anche ad Aristotele, il quale nega che la musica sia oggetto di divertimento o di diletto per se stessa, ma le ascrive una mansione e potenza morale. Essa deve influire sul carattere ed indirizzarlo al bene, ispirando odio e ribrezzo per il male. La musica cattiva e disarmonica, egli dice, deve essere proibita dallo Stato poiché pericolosa e corruttiva dei costumi. La proprietà più importante del suono è quella di costruire.
La Bibbia innizia con le parole: «In principio il Verbo era». Alla parola Verbo non si può dare altro significato che quello del suono orale, ed è noto che molte tradizioni religiose spiegano la formazione dei mondi con la potenza creativa della parola della divinità. Così nel Vangelo di Giovanni è detto pure: «In principio era il Verbo, ed il Verbo era appresso Dio, ed il Verbo era Dio... Tutto si fece per mezzo di Lui: e senza di Lui nulla fu fatto di quanto si fece per mezzo di Lui. In Lui era la Vita e la Vita era la luce degli uomini». Nella Persia troviamo che Ahura-Mazda dice a Zoroastro: «Io ho pronunziato questa Parola che contiene il Verbo e il suo effetto per ottenere la creazione del Cielo prima della creazione dell'acqua, della Terra, dell'Albero, della Vacca Quadrupede, prima della nascita dell'Uomo». Il suono, il verbo, la parola, dunque moto creatore. La semplice vibrazione sonora, la semplice pronunzia della parola non ha però potenza magica se non esprime anche la capacità del pensiero in quanto derivato dalla voce divina. Il carattere magico della musica e delle altre arti in cui il ritmo, la proporzione e l'armonia danno espressione alle profonde leggi delle proporzioni e delle virtù dei numeri, si basa sulla legge dell'analogia, sulla corrispondenza e simpatia universale. A questo proposito anzi A. C. Agrippa dice che: «sopra questo fondamento gli antichi sapienti, conoscendo le diverse disposizioni armoniche dei corpi e degli uomini, secondo la varietà delle complessioni, non invano hanno fatto uso dei canti e della musica». Gli Incantesimi e gli incanti si fanno appunto mediante i canti; le evocazioni e le invocazioni mediante la voce. Ciò spiega le Virtù magiche degli antichi carmina ed il fatto che il poeta, il vate, era il mago evocatore; e da ciò si deduce anche il perché dalla parola latina carmen sia derivata la “charme” dei francesi.
della musica». Gli Incantesimi e gli incanti si fanno appunto mediante i canti; le evocazioni e le invocazioni mediante la voce. Ciò spiega le Virtù magiche degli antichi carmina ed il fatto che il poeta, il vate, era il mago evocatore; e da ciò si deduce anche il perché dalla parola latina carmen sia derivata la “charme” dei francesi.
Chi studi la cosiddetta magia delle parole, che nell'Arabia è chiamata scienza dei cento nomi di Allah e nell'India scienza dei mantra, può avere una prova degli effetti del suono cadenzato e ritmico. Ed è a tutti noto che se un esercito passa su di un ponte è necessario che i soldati cessino di camminare a passo cadenzato per non determinare la caduta del ponte il quale, al ritmo continuo del passo, potrebbe spezzarsi.
 Tutto ciò che è ritmo è ripercussione interiore nell'essere umano e porta anche a delle vibrazioni sia piacevoli che fastidiose a seconda della natura del ritmo. I Dervisci, monaci maomettani che vivono come mendicanti, compiono i loro esercizi religiosi oltre che con digiuni, mortificazioni ecc. anche con suoni ritmici accompagnati da danze e movimenti sincroni dopo i quali cadono in una specie di estasi. La musica jazz è una musica ritmica, sincopata che trasmette al pubblico ed agli stessi suonatori movimenti inconsci, trascinati dal fascino stesso del ritmo, con cadenze uguali che producono una specie di ebbrezza. La musica atonale, che ha per principio la negazione della tonalità, può avere un ritmo nascosto, difficile a scorgersi tra le stonature degli strumenti; forse essa parla egualmente
Tutto ciò che è ritmo è ripercussione interiore nell'essere umano e porta anche a delle vibrazioni sia piacevoli che fastidiose a seconda della natura del ritmo. I Dervisci, monaci maomettani che vivono come mendicanti, compiono i loro esercizi religiosi oltre che con digiuni, mortificazioni ecc. anche con suoni ritmici accompagnati da danze e movimenti sincroni dopo i quali cadono in una specie di estasi. La musica jazz è una musica ritmica, sincopata che trasmette al pubblico ed agli stessi suonatori movimenti inconsci, trascinati dal fascino stesso del ritmo, con cadenze uguali che producono una specie di ebbrezza. La musica atonale, che ha per principio la negazione della tonalità, può avere un ritmo nascosto, difficile a scorgersi tra le stonature degli strumenti; forse essa parla egualmente
all'animo di determinate persone e vuole essere un mistico superamento della materia, e la liberazione assoluta dal modello della natura, ma manca di effetti melodici ed armonici. La dodecafonia, che deriva dalla negazione della tonalità, non ha un ritmo vero e proprio, ma delle cadenze spesso assordanti, senza nesso e slegate. Essa può essere gradita ed avere un linguaggio per un determinato numero di ascoltatori, ma non può avere lunga durata se non sarà accompagnata dal sentimento, il veicolo che parla all'anima attraverso le vie del cuore. Di questo si è reso conto Mahler che nella sua Ottava Sinfonia, ritenuta il capolavoro della musica dodecafonica, si serve dell'espressione lirico-filosofica per innalzarsi nella fede dell'amore universale.
innalzarsi nella fede dell'amore universale.
Il ritmo è la legge regolatrice dell'universo, il principio animatore delle rivoluzioni e delle evoluzioni degli astri: è il respiro del vento, il palpito delle vele, il sussurro delle onde e degli alberi e di tutto ciò che parla, canta e sospira: è la legge di armonia dei cieli e del corpo umano.
Nella musica si ha il riflesso di questo ritmo ed i grandi musicisti ne hanno trasfusa l'espressione nelle loro opere: così in G. P. Da Palestrina abbiamo l'elemento divino che si abbassa fino all'umanità, mentre in Bach l'elemento umano si libera dai ceppi e dalle catene terrene per elevarsi fino al Cielo, per confidargli i suoi dolori, le sue lotte, le sue angosce e per trovare il conforto e la pace. In Wagner, nel Tristano, il ritmo ed il canto ci trasportano alla suprema felicità dell'amore attingendo, come nella iniziazione orfica, alla suprema felicità, che è morte alla vita terrena espressa nel «naufragare, disciogliersi, sparire» ed esprimendo il non essere nella forma più pura della notte, amore perfetto, coscienza di unione con l'Infinito.