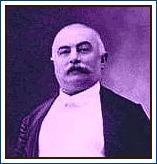Quod fatui contumeliant
Quod fatui contumeliant
Sapientes congremiant.
La vita, nel senso pedestre della parola, è una catena ininterrotta di piccole e grandi pene; la vita morale e spirituale è in lotta perpetua con l’ambiente, tenaglia che preme le nostre elementari libertà. La vita fisica, materiale, grossolana, del nostro corpo lotta perpetuamente con necessità insoddisfatte, piccoli e grandi malanni, il contagio, le epidemie, le infermità costituzionali, e tutta la scala variopinta dei dolori e delle impotenze della nostra carcassa. La civiltà, con leggi, provvedimenti, consuetudini, costumi, transazioni, cerca riparare alla meglio alle necessità liberaleggianti del morale umano, costringendolo, educandolo all’ipocrisia; inverniciandolo per nascondere il colore antipatico delle anime ribelli; profumandolo per impedire che il sentore della volontà di essere contro i simili si discopra.
Al fisico umano cerca riparare la scienza medica ― l’uomo che lotta contro la natura ― per strapparle il secreto della sanità e della invulnerabilità.
Esaminato bene, il bilancio delle pene e dei piaceri, delle ore di delizie, delle dispiacenti, delle pacifiche, delle terribili, e ponderandole con leggero acume pratico, il più beota tra gli umani vedrebbe chiaro che non val la pena il vivere e l’affannarsi a vivere.
Giovani, in lotta con le necessità, le ambizioni, i desideri di godimento, con un corpo esuberante di sangue, di muscoli, di linfa; spesso affamato; eternamente in tensione per acciuffare la fortuna al rapido passaggio, chiamando emulazione, per ipocrisia, ogni agguato che ci lusinga di togliere al nostro vicino il pane e la fama per assidersi al suo posto, e gentilmente schiacciarlo come un insetto immondo.
Vecchi, coi mezzi raccolti in vita, quando molto si potrebbe godere, per l’esperienza, la temperanza, la saggezza, i malanni fisici, l’impotenza, la debolezza, la cagionevolezza, ci riducono a ombre pie o a rassegnati, in attesa della fine.
Eppure, con tal quadro, gli uomini non vorrebbero morire.
La Morte, considerata a sangue freddo, senza bollori bellici, senza esasperazione di rissanti, fa paura a tutto l’uman genere. Vi ci acconciamo perché non si può evitarla. Vi ci ricamiamo su un bellissimo epitaffio filosofico per edulcorare la pillola, che bisogna, volenti o nolenti, ingurgitare, con una smorfia di spasimo o una maschera eroica.
di spasimo o una maschera eroica.
Perché?
Dagli Egizi, dai Caldei, dagli Assiri ai Cristiani, tutte le religioni si sono imperniate su questa assillante idea, paurosa, opprimente del dopo morte.
Il di là della vita, buio, ignorato, discusso con tanti vari argomenti, di chi lo dice lieto e felice e luminoso, come gli spiritualisti a tutto vapore; di chi lo vuol purificatore e ascendente verso la troppo immensa vastità cosmica che si immedesima al Nulla; di chi lo determina al giudizio che Dio farà di noi, come dall’antico Egitto al Cattolicesimo, questo salto nell’oscurità immensa dell’ignoto è tanto universalmente temuto che assume in certi istanti l’aspetto più comico che, se non fossimo civilmente educati a stimar la morte come un istante solenne di una gravità sublime, ci metteremmo a ridere.
Poiché, amico lettore, muore tanta gente nel mondo a ogni minuto dell’orologio del vicino campanile, che serenamente considerato non dev’essere affatto una cosa difficile, né un’azione spaventosa. Il medico Cirillo, motteggiando, soleva dire che la morte deve essere bella, perché dopo il suo arrivo gli ammalati non se ne lamentano mai.
L’epoca nostra, che per scienza di esperimento e per dottrina è meravigliosa, che possiede strumenti e metodi e sale di esperienze che nessun secolo pare avesse possedute ― più di tutte le precedenti ― vorrebbe risolvere il problema del rinnovellamento della vita, il suo prolungamento all’infinito.
Non sono atto a far la storia di tutte le idee sbrodolate negli ultimi cinquant’anni; ma se ne son sentite di tutti i colori.
 Contro le abitudini della dubbia statistica, v’è chi ha sostenuto la media della vita umana a 150 anni ― ma arrivare a 200 sarebbe facile, e raggiungere i 250 una possibilità non estrema.[1] Moltissimi si dettero alla ricerca del mezzo per il ringiovanimento del corpo; Brown-Séquart, al 1889, pareva che avesse scoperto il rimedio vero, entusiasmando tutta la sua generazione, e fece fiasco. Poi arrivano Ancel e Bouin che determinano le glandole interstiziali (1903) e su queste si agitano e operano Steinach in Germania e Voronoff in Francia. Altri, partendo da un concreto ed esplicito risultato della filosofia biologica, sostengono che il prolungamento della vita normale è non solamente assurdo ma inutile. Assurdo, perché le leggi umane non si violano, dice un critico: la natura determina generosamente il limite della vita umana, perché la vita normale dovrebbe sorpassare il secolo, con una maturità attiva feconda di là dell’80° anno (!).[2] Insomma, le aspettative sperimentali sono all’ora presente plaudenti all’opera del Voronoff con la sostituzione di una glandola viva di una scimmia (e sono in esperimento anche le glandole di montone e di caprone), mentre il Lespinasse,[3] americano, si limita alle glandole umane e altri confutano i risultati sostenendo che il complesso dei fenomeni biologici dimostra che non è una glandola sola che fa il buono o il cattivo tempo, ma la sinergia di un complesso di glandole che prese singolarmente non hanno che il valore di un elemento separato e insufficiente.
Contro le abitudini della dubbia statistica, v’è chi ha sostenuto la media della vita umana a 150 anni ― ma arrivare a 200 sarebbe facile, e raggiungere i 250 una possibilità non estrema.[1] Moltissimi si dettero alla ricerca del mezzo per il ringiovanimento del corpo; Brown-Séquart, al 1889, pareva che avesse scoperto il rimedio vero, entusiasmando tutta la sua generazione, e fece fiasco. Poi arrivano Ancel e Bouin che determinano le glandole interstiziali (1903) e su queste si agitano e operano Steinach in Germania e Voronoff in Francia. Altri, partendo da un concreto ed esplicito risultato della filosofia biologica, sostengono che il prolungamento della vita normale è non solamente assurdo ma inutile. Assurdo, perché le leggi umane non si violano, dice un critico: la natura determina generosamente il limite della vita umana, perché la vita normale dovrebbe sorpassare il secolo, con una maturità attiva feconda di là dell’80° anno (!).[2] Insomma, le aspettative sperimentali sono all’ora presente plaudenti all’opera del Voronoff con la sostituzione di una glandola viva di una scimmia (e sono in esperimento anche le glandole di montone e di caprone), mentre il Lespinasse,[3] americano, si limita alle glandole umane e altri confutano i risultati sostenendo che il complesso dei fenomeni biologici dimostra che non è una glandola sola che fa il buono o il cattivo tempo, ma la sinergia di un complesso di glandole che prese singolarmente non hanno che il valore di un elemento separato e insufficiente.
È vero?
Non siamo con i tempi né fuori la relatività dell’ora, superstiziosi della leggenda del millennio apocalittico; ma siamo lontani dall’immortalità di concezione religiosa dell’epoca lontanissima e più recente. La scienza profana ― il cui vanto è il disoccultamento degli antichi sogni dei credenti ― ai suoi adepti lascia sperare o, almeno, intravedere un’immortalità cellulare organica ed inedita, che non è quella dei mistici, tanto meno degli iniziati.
Lancelin[4] asseriva che l’occultismo è uno sforzo perseverante verso la scienza, rovescia l’ipotesi della vera via che le università si tracciano per risolvere l’enigma di Anteo, combattere il divino eroe con le forze della chimica terrena, madre di quelle stupende scoperte che nell’ultima guerra hanno divertito il genere umano.
Raimondo Lullo, i Rosa Croce, Flamel, i Templari, i Rupescissa, Trevisano, gli Illuminati, San Germano, Cagliostro, gli Orfici, i Misteri Egizi, i libri dei primi alchimisti greci, le leggende religiose, paiono sepolti per sempre.
La maestà del materialismo, che si diceva morto con la rinascita dello spiritualismo mistico del dopo guerra, pare che rinserri al concreto le tombe delle fiabe tramontate. Neanche i mocciosi credono più alle fiabe. Ma questo materialismo senza virtù di temperanza è roso da un pantano che domani sarà mare. Né le sette, né i costruttori di nuovi e piccoli templi, né il Sinedrio, né il Santo Ufficio lo demoliranno rinserrando la larga platea in cui cento anni di continue soverchierie lo hanno allargato; non le Università, vecchie di dieci e dodici secoli, perpetue e inesauribili conservatrici di metodi e giudizi che non vedono fine né lasciano, fuori la tradizione, posto alcuno a innovazioni radicali, a dimensioni multiple, senza gridare e senza maledire.
Solo la Nuova Scuola sarà il suo freno e il suo limitatore, un argine e una sintesi.
Un pantano largo pochi metri; largo, direi, quanto un passo d’uomo, che oggi comprende poche intelligenze umane e viventi, domani erigerà, mutato in mare, un contraltare a questa università scientifica di una scienza esclusiva, e parlerà in modo più comprensivo e più umano. Poiché questo materialismo, né morto né moribondo, è dilagato nell’ingiustizia; ha riversato nella mentalità contemporanea la concezione impura di una vita con aspirazione del godimento fisico, illimitato, irragionevole anche nel desiderio di prolungarla per il piacere capronico della moltitudine ― nella quale, nella rapidità delle visioni turbinanti della massima soppressione di tempo e di spazio,[5] non trova che necessaria la sola deificazione della filosofia meccanica di controllo, come una religione dei sensi più gravi, diretti e addottrinati da un’intelligenza che rinnega a se stessa una vita dello spirito, dell’animo, una potenza superiore allo spietato metodo di rinnegare ogni potere al pensiero dell’uomo, in sé, fuori l’adattazione alla materialità della vita. Un serpente e una lingua biforcuta.
La Scuola Nuovissima darà carattere al pensiero dell’interpretazione Pitagorica italica nel magismo e di là e di sopra al magismo, sormontando la particolarità dei rituali alla immortalità luminosa dello spirito intelligente della materia, dal simbolo della sfinge umana o umanizzata, al raggiungimento divino di un atomo materia e pensiero.
È una profanazione dell’alchimismo integrale? è un prendere con un pugno irreverente le parole tesaurizzate dagli scomparsi alchimisti dei secoli vissuti e gettarli nella porcaia? Ma non esageriamo. È assolutamente inutile di erigere una torre Eiffel per piedistallo al buon senso italico, il buon senso della schietta filosofia della pratica Magna Grecia maritata a quell’occulto giudizio di inflessibile temperanza dell’Etruria e di Roma.
Io credo alla resurrezione della potenzialità del pensiero pitagorico ― la Pizia, il Pitone, la spira elicoidale che prende nascenza nell’astrale dell’Italia vetusta e assurge all’imperio della coscienza universa ― e credo a questa missione pitagorica italica come il segno di un rinascimento filosofico, scientifico e artistico impossibile nelle mani che ancora stringono la ferula scolastica del medio evo. È un sospetto o un desiderio messianico? Chi può dirlo? Siamo vicini al duemila. Non si ripeteranno le paure catastrofiche del mille? Non sento ancora le vie predicanti le apocalissi del terrore; la fine di un mondo non è sempre la frantumazione del pianeta tanto piccolo che noi abitiamo, tanto meno può limitarsi ad un diluvio che porti le onde all’altezza del Monte Rosa e ai ventotto vulcani, predetti dal solito geologo americano, che incendiano l’Europa e la riducono in cenere e carboni; la fine di un mondo può essere la morte di tutta una rancida vecchiaia sommersa da un ringiovanimento di luce e pensieri che, sorti dai sepolcreti fatidici, riprendono la missione anticipata e rinnovano, rigenerano idee e visioni, nel mondo esteriore.
universa ― e credo a questa missione pitagorica italica come il segno di un rinascimento filosofico, scientifico e artistico impossibile nelle mani che ancora stringono la ferula scolastica del medio evo. È un sospetto o un desiderio messianico? Chi può dirlo? Siamo vicini al duemila. Non si ripeteranno le paure catastrofiche del mille? Non sento ancora le vie predicanti le apocalissi del terrore; la fine di un mondo non è sempre la frantumazione del pianeta tanto piccolo che noi abitiamo, tanto meno può limitarsi ad un diluvio che porti le onde all’altezza del Monte Rosa e ai ventotto vulcani, predetti dal solito geologo americano, che incendiano l’Europa e la riducono in cenere e carboni; la fine di un mondo può essere la morte di tutta una rancida vecchiaia sommersa da un ringiovanimento di luce e pensieri che, sorti dai sepolcreti fatidici, riprendono la missione anticipata e rinnovano, rigenerano idee e visioni, nel mondo esteriore.
E per la conversione e ringiovanimento di noi stessi? La Morte.
Terribile, spaurita, scheletrica immagine del tredicesimo tarocco, tu fai venire il freddo. Venti secoli cristiani, vedendo le tue ossa scarnificate, si commuovono in noi. Ci comunicano i pensieri allegri delle antiche incisioni e calcografie sulle pareti che riparavano i nostri letti, in camere arcaiche popolate di icone, parate a festa, illuminate da lampade dall’odore di frittura, con un diavolo che ghigna per non poterci afferrare e un angelo armato di scimitarra turca che ci difende. Ci risvegliano l’amore che i buoni teologi domenicani hanno avuto per noi, per purificarci dall’eresia, dall’accusa e dal sospetto di magia diabolica, quelle simpatiche corde che ci incoraggiavano con sorridenti scrollatine a confessare i nostri sabbati e le orge al noce di Benevento, o gli arrosti umani di fra’ Giordano o del priore dei templari, e le processioni di penitenze, e gli allegri carnevali delle abiure e delle pubbliche confessioni.
Sei Śiva? sei il fruscio dei corvi che mangiano i cadaveri delle torri dei Parsi? sei il campanello del viatico? sei il feroce squartatore di Osiride? sei la bocca dentata dei mostri caldei? sei il nulla terribile di un sonno senza risveglio? sei la cenere in un’anfora inutile a cui i nepoti non pensano più?
Tu, o miracoloso, tre volte santo scheletro che raffiguri una fine temuta, hai lo guardo sorridente; tu sei il simbolo della giovinezza. Tu nei tre mondi dello spirito, della materia e dell’atto, sei il rinnovamento. Morte, lasciati guardare in faccia, le ossa monde come denti di sacri elefanti, bianco sudario, sei come la più bella e chiomata fanciulla sorridente e fremente di voluttà nella carne adolescente; se io avessi gli occhi conformati alla maniera dei raggi X vedrei scheletri, come te, e sentirei l’alito della fragrante gioventù: se ci penso, sento a pari fragranza il tuo alito. Non puti di terra umida, di musco, di funghi, di crittogama e di muffa, perché tu, per lo spirito, non sei che la fine di un errore, di un orgoglio, di una schiavitù, di un’ossessione. Se lo scheletro è ancora forte, se la carne è ancora vegeta, le cellule vive, il tessuto delle vene elastico, che bisogno vi è di passare per una tomba e rifarsi? tu, o Morte, sei la soluzione dell’enimma spirituale nell’uomo vivente e nella profonda custodia della sua anima ignota.
 Sei il simbolo della Grande Alchimia, sei il triplo mercurio e il mercurio morto, sei l’Azoth, sine vita, sei l’ala profondamente scura del corvo, sei il sonno preparante il risveglio, il dolore tremendo che precede la nascita del più luminoso figliuolo, dopo l’avatar, la metempsicosi dell’antica e lorda anima nella Vita Nova.
Sei il simbolo della Grande Alchimia, sei il triplo mercurio e il mercurio morto, sei l’Azoth, sine vita, sei l’ala profondamente scura del corvo, sei il sonno preparante il risveglio, il dolore tremendo che precede la nascita del più luminoso figliuolo, dopo l’avatar, la metempsicosi dell’antica e lorda anima nella Vita Nova.
Così Dante iniziò il viaggio per assorgere a Beatrice, la Luce in alto, nell’altezza più eccelsa che è Amore e Luce.
Pharmacum catholicum o Elisire di lunga vita, Arcano Divino degli alchimisti, tu sei la gioventù eterna, spirito raggiante, sul nero fondo del mistero dell’astrale; l’umanità cammina come il Matto dei tarocchi: un cane, la necessità, gli morde i polpacci delle robuste gambe: sempre avanti, più avanti; lontano, più lontano.
Il Papa, la Papessa, l’Imperatore, l’Imperatrice, i quattro re, i cavalieri, le dame, le stelle, gli amanti, i colori[6] passano, ritornano, gli girano intorno, si squagliano, si azzuffano fino a che il giocatore di bussolotti, spinto dal Diavolo beffardo, si decide a bere nella coppa dell’Amore, che è la Morte, e si muta nel giovine Faust, abbagliante, incantatore, indifferente che per non mantenere il patto (la paura) cade nelle musiche degli angeli volgari, il cielo dei volghi… e si salva nel misticismo.
Ed ora ritorniamo alle glandole interstiziali… capite? Dovette essere un disinganno atroce per Orfeo: nel voltarsi indietro, la sua Euridice se n’era scappata con un caporale dei cavalleggeri di Firenze. (O’Thanatos, Anno I n. 3, marzo 1923, pp. 3-8)
************************
(O’Thanatos, Anno I n. 4, aprile 1923, pp. 4-11):
I
Sull’Express Paris-Marseille viaggiai con l’astronomo Camille Flammarion, bel vecchio, ottima cera, animo buono, soprattutto celebre scrittore di spiritualismo ― credente nell’altra vita, nell’altro mondo, nel dopo e nel di là. Nella sua prosa parecchie generazioni di tutto l’Occidente hanno bevuta la coppa della più grande poesia degli spazi interplanetari della fantasia. I suoi volumi sulla morte, con la più grande venerazione all’illustre e caro autore, letti e riletti col fascino dell’argomento e del prosatore, non danno certezza di ciò che ci aspetta dopo la discesa della bara nella fossa mortuaria. Tanta poesia non è che lieta speranza di trovar di meglio di questo cattivo mondo a tre dimensioni; e che la vita umana sia una serie di scene tragicomiche che concludono in una liberazione delle catene terrene e in un passaggio nella zona dei felici. Beati gli uomini che hanno la missione dell’incanto e la certezza di scrivere in prosa il più alto poema della fede: l’esistenza della fine della schiavitù corporea e la conquista di tutto ciò che vivendo quaggiù ci manca: la pace, la luce della mente, la cessazione del dolore e della necessità che ci costringe e sprona ad una lotta di passione e di attesa.
conquista di tutto ciò che vivendo quaggiù ci manca: la pace, la luce della mente, la cessazione del dolore e della necessità che ci costringe e sprona ad una lotta di passione e di attesa.
Non so perché tutta la notte, sonnecchiando in treno, la presenza del grande scrittore mi aveva messo innanzi il ricordo del Mardrus. Si era al cominciamento della infermità di lord Carnarvon, mecenate degli scavi nelle tombe faraoniche nella Valle dei Re. Londra e Parigi si appassionavano sulla sorte dei violatori di cadaveri, e si intervistavano orientalisti e professori di scienze occulte per sapere se l’insetto che aveva punto l’inglese era stato armato di veleno ai tempi del sacerdozio della Magia. In Italia è arrivata l’eco, non la febbrile curiosità londinese e parigina, di questo momento drammatico della superstizione collettiva. In Italia si è poco propensi a commozioni di tal genere. Il Matin poco prima aveva fatto intervenire Mardrus, l’orientalista eminente, a spiegare il soave riposo della mummia nella visione magica e perpetua di una vita non di oltre tomba ma della tomba.
Mardrus è stato il traduttore più artistico ed originale delle Mille e una notte, scrittore efficace che delle magiche novelle ha reso tutto il colore e l’armonia della loro origine; e leggendo la sua spiegazione al giornale sul paradiso delle mummie reali, piena di sobrie osservazioni, io pensavo come non sia differente dopo cinquemila anni quasi la concezione della morte, in due epoche lontanissime, nelle quali né certezza di fede, né dimostrazione scientifica hanno potuto determinare un’idea precisa del dopo.
L’immaginazione e il ragionamento tengono luogo di scienza. L’autore di Lumen, spiritista convinto, poeta degli spazi indefiniti, il simpatico bianco Flammarion coi suoi scritti sulla morte non prova, non dimostra, non convince. L’orientalismo, mettendo alla luce del nostro secolo i procedimenti magici di tutte le religioni ignorate da millenni, traduce e interpreta una poesia diversa, non meno grandiosa, di una tale impressionante novità che gli adulti ne sono sedotti come bambini al racconto di fiabe di spiriti e di orchi. Ma neanche questa seconda poesia ci trova preparati per determinare in noi la coscienza precisa di quel che diverremo.
Mardrus ha la visione orientale della magia sacerdotale come ebbe la finezza della interpretazione del carattere occulto e strano delle novelle arabe.
Questo faraone Tut-ankh-amon, da tremila e più anni, riposava nella sua piccola regia sepolcrale, tra i suoi scrigni preziosi, le sue statuette e le sue dipinture della vita passata.
Arriva dal nord una carovana di mercanti empi con l’idea di violare il domicilio lussuosamente funebre dell’antico monarca, di impadronirsi del suo cadavere e frodarlo del suo doppio,il Ka, che onestamente lo serviva dall’epoca lontana. Delle tre anime, il Ka, più fedele di tutte, gli era restato attaccato; l’uccello intelligenza e l’uccello luce, le altre due, erano volati al Sole, ritornati alla matrice, intelligenza universale.
L’ombra cosciente del sepolto, il Ka, dolorava come il suo re offeso. Mardrus evoca l’origine, l’ora del trapasso; il giorno beato dei funerali, dopo il preciso momento in cui il Pontefice rituale dalle mani pure pronunziava le magiche parole per aprire la bocca della mummia. Dall’istante in cui queste parole dal gran sacerdote erano dette con voce giusta e l’intonazione che arriva,[7] la mummia inintelligente e assonnata muta bruscamente di condizione. La morte è in Egitto un mutamento di stato: si muore come si va a nozze, al tutto è necessario solo un buon prete officiante: un mago incantatore di forza.
Chiusa nel suo ipogeo, tutte le cose che vi sono rappresentate hanno vita. La mummia comincia, vivificata, a vivere in tutta verità servita dal suo doppio che abita le statuette incantate. E così immagini,  parole, geroglifici e statue fanno il loro dovere. Così, dice l’orientalista, la parola luce diventa sole o fiamma illuminante; la parola focaccia diventa un vero odorante pasticcino ― e ad un cenno volitivo della mummia ogni figura si anima, la ballerina danza e i musici cantano, il profumiere offre le sue essenze al Faraone dorato, l’intendente porta le oche imbottite, l’acrobata favorita inizia le sue movenze seducenti… ed è una felicità perpetua, «deliziosa come il profumo del lotus, l’aria libera dopo una infermità, come il riposo sulle rive di un paese di ebbrezza».
parole, geroglifici e statue fanno il loro dovere. Così, dice l’orientalista, la parola luce diventa sole o fiamma illuminante; la parola focaccia diventa un vero odorante pasticcino ― e ad un cenno volitivo della mummia ogni figura si anima, la ballerina danza e i musici cantano, il profumiere offre le sue essenze al Faraone dorato, l’intendente porta le oche imbottite, l’acrobata favorita inizia le sue movenze seducenti… ed è una felicità perpetua, «deliziosa come il profumo del lotus, l’aria libera dopo una infermità, come il riposo sulle rive di un paese di ebbrezza».
Pensavo a questa magia incantatrice delle tombe millenarie, pensavo a quel che scrivono i mistici della vita dello spirito, dopo venti secoli cristiani!
Noi non abbiamo progredito di un decimo di milionesimo di millimetro nella scienza dei poteri dell’anima. Siamo sull’orlo di un pantano melmoso che si chiama volgarizzazione, ed in questa pozza si affonda il piede dell’audace che va innanzi parlando, discutendo, pubblicando.
I metodi per l’investigazione della scienza delle anime non devono essere identici agli ordinari adoperati per un secreto di metallurgia. Diversamente il processo della morte resterà il grande arcano impenetrabile.
Dice la moltitudine, la plebe scientifica, quella che brevetta i ritrovati e le scoperte industriali: se sapete e potete provare, venite, io vi poserò sul capo una corona di alloro. Ho paura che questo arboscello di lauro nobilissimo non sia stato seminato ancora, e le sue fronde non siano spuntate per fabbricare la corona per lo scopritore di qualche verità preclusa alle masse. Il Filalete, in uno dei suoi curiosi scritti, insegna a non vendere l’oro che riuscirai a fabbricare. Chi riesce a sapere che bisogno ha della benedizione e di un brevetto? E se proprio le masse dovessero ignorare certe verità?
II
Se Trimalcione offriva per antipasto ai suoi convitati uno scheletro d’argento per incitarli a godere la vita, bisogna intendere che i Romani del suo tempo non avevano paura della morte. Sublimi padri nostri, voi non eravate attaccati dalla peronospora neogiudaica che da venti secoli fa considerare la vita come un’espiazione. Di che? di quale colpa? Voi gente eroica, equilibrata e giusta ammiratrice di ogni follia religiosa, alla morte assegnavate un posto di persona noiosa e necessaria, come a chi governa le scodelle ingrassate della cucina. Nessun tremito e nessuna tenerezza, né l’immagine di Caronte, né il giudizio di Minosse vi preoccupavano; bastava l’amico Mercurio per accompagnare la vostra personalità immortale sulla via degli Elisi. E quando il simposio tra anfore di vino odorante e donne coronate di rose si protraeva oltre il tramonto, gli schiavi, portatori delle faci, pronunziavano il vivamus, pereundum est: godiamo la vita, perché cesseremo di vivere.
godiamo la vita, perché cesseremo di vivere.
La Notte, divinità nera, figurazione delle tenebre cosmiche, da cui procede la creazione delle forme, pei Greci e Latini fu madre del Sonno e della Morte. Il dormire e il morire figli della stessa dea, a cui si sacrificava il gallo, il nunzio della luce,[8] che fu simbolo di Esculapio che lo portava in pugno. Dunque dormire è morire, la Morte è comeil Sonno. Attraverso l’ellenismo è artistica ogni forma dell’esagerato e difficile simbolismo orientale: l’oscura notte nelle mitologie poetiche fu qui e là madre della lunga teoria delle più buie divinità, della Paura, del Dolore, delle Parche, della Concupiscenza, e della Discordia, dell’Ostinazione e del Destino ― ma il Sonno e la Morte restano confissi latinamente come fratelli, ignorati, tenebrosi, somiglianti. Morire e dormire.
Fui, sum, ero.
Se affacciandoti nell’abisso profondo dell’astrale tu domandi chi sia il tuo dio, la Voce ti risponde: Io sono colui che fu, che è, che sarà in eterno. Né la Morte mi cangiò, né le ceneri disperse del mio cadavere di ieri hanno menomato la potenza dell’Essere. Orfeo si volse a guardare la sposa pur sapendo che l’avrebbe perduta, e grecizza l’enigma osirideo egiziano nel mistero della tragica morte tra le baccanti innamorate, che ne fanno a brani il corpo, e il suo capo reciso, portato dai flutti dell’Egeo, cupamente se ne dolevaai piedi delle rocce di Lesbo.
Osiride e Orfeo, iniziatori di civiltà. ― Cicli sacri personificati; sacri perché develavano alle plebi selvagge che oltre la morte una parte di noi si trasforma e vive d’una vita diversa per continuarsi. Il serpente che nel letargo muta la sua pelle. Il letargo non è qualche cosa più del sonno e poco meno della morte?
Le leggende dei culti, la passione di Marduk, la passione di Osiride, la passione del Cristo, sono lacrime e martìri, morti e resurrezioni. Osiride vinto da Seth è assassinato, ha il corpo fatto in quattordici parti disseminate senza pietà sulla terra d’Egitto. Iside le ricerca con amore ed in ogni sito ove una parte dispersa è ritrovata, un tempio osirideo vi è costruito. Osiride rinasce nella vita vegetante e animale e Iside nel dolore della pia ricerca dona agli uomini i riti dell’immortalità.[9]
III
Dopo tanti secoli di storia dimenticata, noi ci domandiamo, come seimila anni fa i Caldei e gli Egizi, la soluzione dell’enigma d’una morte, quando, per le morti successive di miliardi di corpi umani scomparsi, la crosta del piccolo pianeta nostro dev’essere impastata di residui materiali dei nostri predecessori, antenati o padri. Se il fratello che ieri pensava e parlava ci muore ancora rigoglioso di vita, innanzi al suo cadavere domandiamo se egli è distrutto o è volato come invisibile farfalla in libertà e pace, in aura più ideale, in regioni mai sognate, in una vita nuova agli uomini mai svelata. Resta di lui la sola cenere del corpo che si dissolve negli elementi terreni, o la più tenue essenza del suo soffio di vita vede, pensa, gode e soffre come innanzi? Se a lui rivolgiamo la parola, ci sente? Se lo pensiamo, il suo pensiero ci intende? Se nel dolore del nostro affetto evochiamo le sue forme amate nelle quali egli ci ha amato, può, commosso dallo stesso amore, raccogliere gli atomi dispersi del suo corpo svanito e  apparirci e parlarci? E quando, negromante incosciente, nel mio dolore allucinante, lo plasmo e lo ascolto e ne riconosco l’accento e ne ricordo il pensiero, sono io sull’orlo della follia o in presenza di un intervento di oltre tomba? E se egli sotto forma diversa vola o è volato libero intelligente e felice, quale lo spazio che lo ha accolto? qual è la concezione nostra di una dimensione fuori le note della volgare geometria euclidea?
apparirci e parlarci? E quando, negromante incosciente, nel mio dolore allucinante, lo plasmo e lo ascolto e ne riconosco l’accento e ne ricordo il pensiero, sono io sull’orlo della follia o in presenza di un intervento di oltre tomba? E se egli sotto forma diversa vola o è volato libero intelligente e felice, quale lo spazio che lo ha accolto? qual è la concezione nostra di una dimensione fuori le note della volgare geometria euclidea?
IV
O filosofi, o credenti, o religiosi del serafico francescanesimo, non trepidate nei vostri ragionari e nella vostra fede.
Se il ragionamento o la fede vi manca, non vi resta che la negazione. La scienza umana, la officiale,[10] non vi conforta, nega. La scienza che ha inventato le polveri onnipossenti per squassare la terra e i fumi pestiferi per uccidere gli uomini, i velivoli per montare alla luna e il mezzo per parlare agli antipodi i messaggi e i suoni, questa scienza onnipotente a cui nessun elogio è negato, non può dirci che oltre la tomba si vive e si ama. Siamo ancora in piena eterodossia se crediamo agli spiriti dei morti, ai fantasmi, alle anime del purgatorio che si manifestano ai vivi.
La scienza nega e la religione proibisce; il prete celebrante la messa recita ancora la preghiera all’arcangelo Michele affinché sconfigga e dissolva i demoni che fanno da spiriti di morti sulla scena degli incanti e attentano alla purità dei creduli.
Scienza e religione ci lasciano attoniti, fuori la fede e la ribellione.
V
L’iniziatore si affaccia.
Esiste il Maestro che ha risoluto l’enigma della sopravvivenza? Ermete, Pitagora, Numa, Orfeo non hanno avuto continuatori? come lo spirito del Cristo aleggia nei templi paolotti, il loro, che era sapienza di rivelatori, non rivive in discepoli antichi votati alla missione pontificale?
Questa iniziazione è fuori l’orbita della scienza delle università ed è in contrasto con la tradizione religiosa cristiana.
Io credo che non bisogna esser vili nella critica delle idee pseudo iniziatiche e mistiche che ci piovono da ogni parte, e di questa viltà, per amore di pace, siamo un po’ tutti poeticamente intinti. Noi apriamo le braccia a tutti i mistici e rispettiamo tutte le panzane vomitate dai più fantasiosi. Siamo teneri ammiratori dell’oriente indiano e del favoloso Tibet; ammiriamo volentieri il taoismo, il confucianesimo; andiamo in brodo di giuggiole per un po’ di buddismo annacquato; i cenacoli della tedescheria ci commuovono e i romanzieri dell’ignoto ci paiono messi della provvidenza.
Ma queste cose, per chi ha sete di essere distratto, sono passatempi piacevoli; tra una tazza di tè e un biscottino zuccherato, darsi l’aria di sapere gli arcani dell’invisibile e aspirare alla sapienza omnisciente degli spiriti che stanno a dieci metri da Padrebacco è grazioso.
Questa mancanza di opportunità e questa consuetudine a lasciar dire e a lasciar fare, generano la confusione e il pasticcio delle idee nel grosso del pubblico, attratto per debolezza infantile congenita verso il maraviglioso di ogni specie. Tanto più se ci entra per intingolo qualche parola soffiata alla giapponese o un gargarismo indiano o tre gutturali ebraiche!
Quella che si dovrebbe intendere per iniziazione è tutt’altra cosa. Non ha da veder niente con la mistica. È un materialismo di altro genere, perché forma, costruisce, educandoli, gli operatori, i sacerdoti celebranti dalle mani pure e dalla parola del tono giusto, come il dottor Mardrus traduce dai geroglifici, per incantare e rivivificare le mummie.
L’iniziazione magica è cosa, più che aristocratica, regale.
Il suo simbolo è la corona. Non quella di alloro pei poeti. La corona che dà la potestà imperatoria. La teocrazia va intesa così. Perciò Éliphas Lévi, che ha una tenerezza ebraizzante spiccata, avrebbe voluto rendere le rugginose chiavi dell’ebionita Caifa atte ad aprire le porte dei cieli. Il triregno è un simbolo giusto: una splendida etichetta dorata su di una bottiglia vuota.
L’iniziazione alla Grande Magia Imperatoria comincia con la Morte, la Morte che è una purificazione incompleta, perché la rinascita porta in germe la memoria della vita vissuta anteriormente. Il cattolicesimo è infiltrato di riti magici ― dall’epoca in cui elementi gnostici ne manipolavano la liturgia. Éliphas Lévi strizza un’occhiatina maliziosa, quelle famose chiavi hanno bisogno di essere unte, con olio di sapienza, per aprire col paradiso la develazione dei misteri.
Ciò che gli egittologi non hanno ancora capito.
La rivivificazione dell’ombra della mummia laccata e fasciata è l’incanto perché, ritornando a vivere la vita umana, il Ka e gli altri due complici si riuniscano di nuovo per continuare l’identica felicità della vita vissuta.
Lo stesso augurio non occorre fare a chi ha menato una vita di stenti e di privazioni. Il cristianesimo ha la assistenza ai moribondi: assistere un moribondo cristianamente, cattolicamente, significa ipotecare alla stessa lugubre fede paurosa la vita futura. Vita futura? ma non fraintendiamo, non nei cieli, non nei Campi Elisi, ma in terra, alla reincarnazione prossima.
L’iniziatore vi dice: non credere. Tra la fede e la scienza vi è un abisso. L’iniziatore non dice credi, dice prova. Vuoi sapere il dopo morte? O prova a ricordarti donde vieni, o prova a morire per ricordare poi. E, mostrando una statuetta di Mercurio pronto a spiccare il volo, l’iniziatore ti invita a non bere vino: regime secco, all’americana, non ubbriacarti, se non vuoi avere la televisione delle sante del paradiso che sono passabilmente brutte ― come Simone e Paolo, due tipi bruttissimi ingentiliti dagli artisti italiani, quando crearono la bellezza mistica, luminosa, ideale, come non è mai stata concepita dopo l’arte ellenica, plasmatrice di altra bellezza.
Chi ha visitato gli scavi di Pompei deve ricordare che sul muro adiacente alla bottega di un unguentario sono scalfite delle parole latine che quasi suonano così: Oziosi, non vi fermate, procedete per la vostra via. In altri termini: qui non vi è miele per chi non è pronto a sfidare i veleni della morte: questa la traduzione che l’iniziatore incide sulla porta della sua bolgia.
Morire è risorgere; iniziandosi, la morte è la vigilia del risveglio. Gli oziosi, gli sfaccendati, i curiosi, i grammatici e i gazzettieri sono pregati di procedere oltre. Troveranno più avanti più facili e seducenti botteghe. Una tazza di tè e dei biscottini all’essenza di arancia. Un bel discorsetto per acquistare la chiaroveggenza in due sedute o diventar magnetizzatori in otto giorni e poi avere il successo nella vita. Ideale alla maniera moderna di comprendere l’utilità di sapere qualche cosa che possa condensare il piacere di vivere. E non è un’idea balorda: se il superuomo ci promette facile conquista di un paradiso di oltretomba, potrebbe anticiparci un po’ di felicità in questa valle di lacrime: Budda era tondo e grasso come un priore dei domenicani, e gl’iniziati più famosi non mancarono mai d’un po’ di polvere di pirlimpipì per convertire i manichi delle scope in barre di oro.
grammatici e i gazzettieri sono pregati di procedere oltre. Troveranno più avanti più facili e seducenti botteghe. Una tazza di tè e dei biscottini all’essenza di arancia. Un bel discorsetto per acquistare la chiaroveggenza in due sedute o diventar magnetizzatori in otto giorni e poi avere il successo nella vita. Ideale alla maniera moderna di comprendere l’utilità di sapere qualche cosa che possa condensare il piacere di vivere. E non è un’idea balorda: se il superuomo ci promette facile conquista di un paradiso di oltretomba, potrebbe anticiparci un po’ di felicità in questa valle di lacrime: Budda era tondo e grasso come un priore dei domenicani, e gl’iniziati più famosi non mancarono mai d’un po’ di polvere di pirlimpipì per convertire i manichi delle scope in barre di oro.
(O’Thanatos, Anno I n. 5, maggio 1923, pp. 4-11)
VI
Queste note brevi e varie sulla morte, che è l’alfa e l’omega di tutte le religioni e di tutte le filosofie, sono piccole luci pel lettore acuto che si avvia, come Teseo, a scovare il Minotauro nel laberinto. Queste chiose sono moniti iconoclasti; le statue monumentali delle credenze superstiziose di altre fedi e di altre dottrine, denaturate dai commenti e dalla malevolenza delle religioni imperanti, cadano spezzate, in frantumi, in polvere, sguazzanti in laghi di inchiostro.
Io scrivo pel mio unico lettore acuto che voglia prestarmi attenzione, purgato, se è possibile, delle idee assorbite per secoli lunghi e dolorosi nella formazione della sua anima cristiana. Questo unico lettore è là, in un cantuccio oscuro, pronto alla critica, curioso di apprendere, avido di teorie inaudite; fermenta nel suo animo la ribellione sorda alla nuova ricostituzione di un occultismo, a base di teologia tomistica, di cieli religiosi sovrapposti, mescolando, a convalli, scene di misticismo di ogni colore. Questo unico lettore che domani sarà completamente purificato dalla suggestione atavica, e della più prepotente, del gruppo sociale in cui è cresciuto e vive, vedrà ingrandite le fiammelle delle mie lucerne, diventate le grandi luci di tempi ignorati.
La confusione delle idee, delle teorie, misticherie, mistagogie, esegesi è tale e tanta che il campo visuale della natura, nella sua semplicità, è ridotto a niente. Ed ora che alla partita di piacere si sono aggiunti gli orientalisti, babele trionfa. La sapienza pratica degli americani ci promette di fabbricare gli iniziati a serie, come le automobili, le calzature, i cappelli, le saponette.
Il valore grammaticale di iniziato non è l’iniziato nel senso magico: iniziazione è cominciamento, da iniziare, cominciare.
I nostri antenati avevano la debolezza, forse necessaria, di creare parole a doppio senso ― gittavano in padella un vocabolo che rassomigliava o consonava ad uno di senso volgare, e poi... qui vult capere capiat.
Certo profanamente initio ed initiare volevano dire consacrare, introdurre ai misteri ― ma se vi ha qualcuno che voglia perdere tempo, rifletta che in-itium ed ex-itium, il principio e la catastrofe o la morte, hanno la seconda parte della parola che è identica; che ito, itio, it, andare con frequenza, andare, muoversi, sono voci di moto. Nell’Urbe arcana, dove l’iniziazione non appariva e le cene delle ordinarie sedute[11] passavano per convegni dilettevoli,[12] Roma, Orma, Ramo, erano forme esteriori di reconditi significati.
Ora io voglio dire che anche gli egittologi credono che la parte dei misteri non pubblica fosse riservata agli iniziati, parte dei misteri drammatizzati da mimi, come quelli della Grecia, come più tardi, nell’oscuro medio evo, in Italia e in altri luoghi di Europa. Ed è un errore, perché coloro che assistevano a queste celebrazioni arcane non erano iniziati alla magia sacerdotale, ma alla significazione dei miti, delle favole analogiche che la plebe dei misti non doveva intendere.
Iniziazione vera era riservata a chi doveva diventare un sacerdote, e non dell’ordine inferiore dei celebranti i misteri, ma della gerarchia più elevata, tra i quali i facitori di miracoli erano frequenti.
Ecco perché ho detto che i grammatici, i filosofi, i parolai, i mistici non sono iniziati: chi doveva arrivare, uomo o donna, era preso ed educato con un allenamento lungo, faticoso, severissimo, come il sacerdozio cristiano non ha sentito il bisogno di educare gli aspiranti agli ordini sacri.
I nostri contemporanei non saprebbero concepirla un’educazione alla magia operante: bastano i libri, le belle discorse,l’invenzione di parole bisbetiche e l’orizzonte magico è conquistato; le scienze occulte, contrariamente all’indicazione che farebbe insegnarle nei luoghi più nascosti e nel silenzio più profondo, si propalano a colpi di eloquenza e volumi rivelatori di verità e di enimmi.
Oziosi, procedete oltre.
Il pubblico contemporaneo comprende un’educazione e una vita rigida, in allenamento continuo, con sorveglianza severa ed ininterrotta, per un pugilista che deve aspirare alle vittorie delle arene e guadagnare ricchezze; ma non intenderebbe che un tirocinio austero di trent’anni, con regole imprecise e non spiattellate nei giornali curiosi, possa mutare un uomo in un semidio.
La cattedra l’ha insegnato: non vi è che la follia o la superstiziosa banda degli impostori. La scienza è onestamente franca, studiate e saprete tutto; noi diciamo lo stesso: studiate, formandovi un corredo di possibilità paradossali, ma praticate, allenatevi e sappiate non dire, né pensare tanto meno di stampar libri. Ma chi prende sul serio un invito a far cosa che vale pena e fatiche di tutte le ore?
VII
Più che molti santi della chiesa, Kardec, Léon Denis, d’Alveydre, Schuré, Flammarion e i mistici numerosi contemporanei, di seconda linea, hanno diritto all’umana gratitudine: creature bersagliate dalle tempeste della vita, dalla violenza di sciagure improvvise, da turbamenti spirituali, brancolanti nel buio di una mancanza assoluta di fede nella religione dei padri, doloranti e isolate nella vita dopo la sparizione di persone carissime, hanno trovato salvezza, oblio, speranza, fede viva assai spesso alla lettura della prosa poetica di questi supremi artisti della consolazione. Che importa se facendo ballare un tavolo a tre gambe non si produca fenomeno approvato dalla scienza officiale e dal sacerdote? Le pene dell’anima vi trovano conforto e gli spasimi un sollievo, e questo è, incoscientemente, un atto di magia consolatrice delle anime sanguinanti.
Un poeta americano, Mortimer Clapp, ha scritto che la realtà (la verità) è un momento furtivamente lucido tra due sogni.[13] La concezione della vita, pensiero e visione, come un sogno, fu formulata dal Calderón;[14] il vivere è un sogno e ogni sogno è vita.[15] Un anonimo, preparatore della Rivoluzione del ’93, scrisse che l’utilità delle religioni è di sovrapporre alla crudeltà delle pene di ogni momento una speranza continuata in un sogno che fa capo alla morte, l’ultima pena[16] e l’ultimo sogno.
Come ogni volta che una grande catastrofe si abbatte sugli uomini, l’immediato periodo del dopo guerra ha generato un’inondazione mistica in tutta l’Europa; se ne sono avvantaggiate le religioni per quel credo quia absurdum che è la base della contraddizione tra ragione critica umana e fede. Ma un’ondata di scetticismo, di ribellione, di protesta, ha invaso per un più lungo momento l’umanità, ribelle alle menzogne convenzionali sulla potente azione dei cieli misericordiosi, che hanno assistito imperterriti ai clamori delle vittime: secondo misticismo di reazione alla divinità. Dei due stati della psiche occidentale, la letteratura ne ha risentito come espressione artistica del sentimento, la morte, la filosofia della morte, la psicopatia della ribellione alla morte. Il disinganno dei patimenti lunghi. La ripugnanza a immolarsi per cause ingiuste, ove predomina la malvagità dei conduttori di popoli, asserviti alla schiavitù inutile di sfidare la morte o la mutilazione per una vanità di nazioni che i venti secoli di eresia cristiana non hanno modificato. Vanità la vita, vanità la morte, vanità la gloria e il dolore: il sogno dell’esistenza, tra un cumulo immenso di vanità, s’interrompe nel momento furtivamente lucido in cui consideri la verità nella rapida e folgorante luce della sua integrazione divina, la verità miserabile della vita umana, da cieli mutissimi non protetta, tra l’indifferenza di dii o di un solo Dio che non intervenne che a sproposito nelle faccende terrestri; crudeltà o desolazione o spasimo.
 L’iniziato cerca l’elisire per vincere la morte. Prometeo? No. Prometeo, nello splendore della favola sapiente, nell’arte greca, nello scettico poetico sorriso latino, è la scienza umana, quella della società dei mortali nella convivenza della terra. L’uomo audace nella sua investigazione che monta alla conquista di un dominio in cui la Divinità invisibile è confinata, appartiene alla boria delle umanità. La concezione del Vico.
L’iniziato cerca l’elisire per vincere la morte. Prometeo? No. Prometeo, nello splendore della favola sapiente, nell’arte greca, nello scettico poetico sorriso latino, è la scienza umana, quella della società dei mortali nella convivenza della terra. L’uomo audace nella sua investigazione che monta alla conquista di un dominio in cui la Divinità invisibile è confinata, appartiene alla boria delle umanità. La concezione del Vico.
L’iniziato si propose il solo problema della continuità di coscienza, sorpassare il fiume dell’oblio, il pittoresco Lete, continuando senza interruzione il sogno della sua integrazione nei poteri divini.
Prometeo, piccolo dio, semidio, aspirante a sostituirsi al Dio, è la grande università della scienza dei volghi che sfida l’ignoto, nell’enunciazione della potestà meccanica di tutte le leggi infallibili, ininterrotte, della natura terrestre. La rassegnazione non è che filosofia o viltà. Il laboratorio mistico del cristianesimo cerca da secoli di inocularla nella mentalità dei popoli; come la volontà di Allah nell’Islam; come l’ineluttabilità delle fasi pel divenire nell’oriente buddico. Ma il pecorume occidentale si rassegna nell’impotenza dell’atto ribelle? Nell’ora estrema, innanzi alle ingiustizie stridenti, le anime più vecchie, le più antiche, le più libere si rivoltano: il mito della ribellione degli angeli deve essere eterno, sopra il piccolo pianeta che abitiamo, e nelle infinità dei mondi animati, nei sistemi solari dell’Universo inconoscibile: chi sa quali rivoluzioni spirituali nascondono le stelle scintillanti nell’azzurro cielo d’Italia, che sardonicamente, in calma apparente, guardano in eterno alla nostra povertà di mente! ai nostri piccoli orgogliosi dolori, di cui scriviamo l’epopea pazza, addebitandoli agli dii indifferenti che ci dovranno guardare, chi lo sa?, con la stessa annoiata curiosità con la quale noi contempliamo un formicaio o un nido di vespe arrabbiate!
Il sacerdote mago dell’Egitto operava l’incantesimo della mummia, la risvegliava, la preparava al viaggio, talismani e immagini nelle fasciature; le insegnava le frodi per corbellare la divinità, nel lungo itinerario per montare, incolume, senza ostacoli, alla residenza delle cause. Filosofo teocratico, il pontefice doveva avere innanzi agli occhi il cammino nel regno delle ombre, la via sempre affollata che i morti di tutte le ore percorrono. Il libro dei morti è un monumento. Vale il peso e il lavoro della piramide di Cheope. Fortunato chi vi legge bene. La magia vi metteva il suo sigillo. Anime ribelli dovettero esservi a centinaia anche allora, in epoca di schiavitù forzata, egualmente feroce che le schiavitù dell’attuale civiltà, dell’Occidente empio, che cova l’incendio e i massacri immani.
L’iniziato deve vincere la morte, sorpassare la schiavitù della legge inesorabile. Immortale come l’invenzione di Dio. L’enigma vivente. Vedi, o lettore acuto, come siamo lontani dal misticismo religioso, dalla filosofia dell’eguaglianza dei valori umani, dall’anarchico misticismo del non valore della vita dell’uomo, dalla rassegnazione, dalla fatalità islamica, dalla ineluttabilità karmica.
Credo, o acuto amico, che nessuno t’abbia mai parlato così: faccio da Lucifero, con queste noterelle che sono piccole luci, in attesa, se tu sei libero, che diventino fiaccole irradianti.
Vincere la morte.
VIII
Religioni scomparse che hanno governato l’anima dell’uomo per millenni, credettero agli dii ― e tra gli dii a un dio più potente. Gli dii, grandi e piccoli, invadenti la vita umana. Spesso dii contrari e dii amici si contendevano, come in lotta invisibile, la felicità di una creatura terrestre. Guerrieri protetti dall’uno erano avversati da un altro dio. Leggete la guerra di Troia. Israele, che aveva vissuto nella servitù babilonese ed egizia, sfoderò il dio unico, poi il profetismo e il messianismo. Cacciato dalla Palestina invase il mondo, con Geova, a bandiera spiegata, aspettando da venti secoli lo stato di Sion.
Monoteismo? Politeismo? Ateismo?
Lucifero, sardonico, come le stelle delle notti serene, tra il ribelle e il faceto, traccia nell’aria il segno misterioso della mano: ― e se la concezione dell’errore è la deificazione dello spirito e della ricerca e dell’ipotesi dell’uomo?
Lucifero demolitore. Prometeo bestemmia.
Questo Giove unico, prepotente, ultrapotente come una stazione marconiana, è il più ingiusto e tiranno che giammai fu concepito. Come Ea, come Nun, come Jahvè ebreo. Negriero. Padrone di turbe di schiavi. L’umanità una creazione sbagliata. Un aborto. Creò imperfetto l’uomo per farsene un lacchè; peggio, per poggiargli il piede sul capo e obbligarlo a respirare il dolore. La morte dopo una vita effimera. La cremazione del cadavere. Il pianto e la miseria dei reietti e degli impotenti.
che giammai fu concepito. Come Ea, come Nun, come Jahvè ebreo. Negriero. Padrone di turbe di schiavi. L’umanità una creazione sbagliata. Un aborto. Creò imperfetto l’uomo per farsene un lacchè; peggio, per poggiargli il piede sul capo e obbligarlo a respirare il dolore. La morte dopo una vita effimera. La cremazione del cadavere. Il pianto e la miseria dei reietti e degli impotenti.
Allora, come oggi, come domani, come sempre. Mutare il nome a Giove, resta il tipo del cattivo padrone e del pessimo padre. La misericordia, la rassegnazione, la viltà inventate e suggerite dai propiziatori, per compiacere, calmare, impietosire ilpessimo governatore. Se siamo imperfetti, malati, miseri, disordinati nei desideri, violenti, crudeli, è lui il colpevole, ci ha fabbricati lui così. Gli conveniva di non avere per sudditi persone diritte e immuni dalla caducità: non toglie il figlio amato alla madre disperata? non lo sposo alla sposa? non il padre ai figli miserabili? non nega il pane all’affamato? il tetto al vagabondo? Il sacrificio è l’azione che più gli diletta le ore oziose. Il sacrificatore veggente contemplava gli dii a frotte, a nembi, come le mosche, accorrere ad inebriarsi del sangue della vittima immolata.
Il feroce piacere della morte violenta è di origine divina. Il nettare dei calici nei celesti simposi doveva sentire di sangue, e l’ebbrezza di crudeltà, e il riso balordo della ubriachezza saporito dei dolori degli umani!
Prometeo, il formatore dell’uomo di loto,[17] al quale Minerva,[18] l’intelligenza divina della sapienza umana, portò il contributo dei doni celesti. Il piccolo dio sentì la logica rivolta, orgogliosa di lotta, contro questo Padre senza visceri per i lamenti della larga figliolanza ― e divenne scienza, investigazione, audacia, temerità: divenne sapienza umana, pronta a scalare i più lontani Olimpi.
La favola.
Prometeo fabbrica l’uomo di loto, Minerva ammira la creazione da lui compiuta e vi trasfonde la timidezza del lepre, l’astuzia della volpe, l’ambizione del pavone, la crudeltà della tigre e la forza del leone. A Prometeo domandò che cosa dovesse prendere nei cieli per completare la sua fattura, ePrometeo chiese di andare egli stesso nelle divine regioni per scegliere a proposito: accompagnato dalla dea, rubò in alto il fuoco sacro e lo portò sulla terra. Ira di Giove, che scaraventa sulle sue braccia Pandora. Giove e gli dii tutti, visto l’uomo fabbricato da Prometeo, crearono anche essi un essere vivente, una donna, a cui ogni divinità fece dono di sue virtù. Bella, seducente, irresistibile, giovane, il vecchio dio la inviò a Prometeo perché se ne innamorasse, e le dette un cofano sigillato perché l’offrisse in dono di nozze al suo sposo.
Prometeo, astuto, si sottrasse all’inganno e rifiutò la seduzione, ma volle egli stesso prendere per l’inganno Giove e costui, irritato ed implacabile, comandò a Vulcano di incatenare l’incauto piccolo dio ad una rupe. Eschilo ne ha scritto la tragedia: immensa come la sanguinante poesia della scienza dell’uomo, attraverso epoche lunghissime, contro il prepotente malvolere del destino inafferrabile.
Prometeo[19] invoca cielo, terra e mare, l’etere, il vento, il sole a testimoni dell’ingiustizia dei numi: «Giove voleva distruggere gli uomini per rinnovare il mondo, gli dii che gli facevano corona acconsentirono: io solo ebbi il coraggio di salvare l’umana razza: ecco il mio delitto. Gli uomini selvaggi vagavano alla ventura, io detti loro le leggi, costruii case e templi, insegnai loro il corso degli astri, calcolai il tempo, svelai il mistero dei numeri, insegnai loro a coltivare la terra, a domesticare il cavallo, a navigare: ecco la mia colpa».[20]
O simpatico Prometeo borbottone, tanto hai fatto contro padre Giove intollerante, invidioso, ingiusto; tutto hai potuto ottenere col fuoco rapito ai cieli[21] e non hai sfatato l’Olimpo; dalla sua tirannide non hai emancipata l’umanità schiava. Sei restato confisso alla montagna, scheletro della terra, bestemmiando: ma perché non hai insegnato all’uomo come vincere la morte?
Non hai vinto il destino degli umani. Non lo potevi? non lo puoi vincere? la tua sapienza non lo potrà mai? Dureranno in eterno i periodi di veglia e di sonno, di luce e oscurità, di vita e di morte? Il sole sorgerà per infinite aurore, tramonterà in continue notti, in eterno? Ma che il tuo genio di creatore in lotta con i numi non sia uno dei paradossi del genio alla maniera del Lombroso, che precipita nel suicidio della razza umana? Che provocata dalla temerità delle tue conquiste, incosciente, non prepari, nuova Atlantide, diluvi e sparizioni di razze edi continenti?[22]
E questo il tuo delitto? sarà questo il peccato originale delle razze future nei futuri millenni?
Lucifero ironico, come le eterne stelle del firmamento, traccia nella notte crepuscolare il segno della mano: ricerca, o mortale; il ponte copre il Lete, sorpassalo, non ti immergere nell’oblio. Ricorda l’ieri lontano, Osiride nel breve piano del delta, Giove nella reggia del piccolo Olimpo, Geova minaccioso e ringhioso sulla terra di Sion, Assiriel fastoso, opulento a Ninive, a Babilonia, a Tiro! Sorpassa l’oblio, come hai sorpassato la vilissima età della paura; profetizza, alla maniera giudaica, come Ezechiele, come Esdra, come Baruc: il lontano domani è dei volghi, delle masse, delle ambizioni; le plebi saranno rinnovate e nuove plebi monteranno; la terra vomita i suoi semi, li fa germogliare in piante rugose e nane, in arbusti fiorenti, in alberi pomposi di foglie e di frutta. Apri la mano nel buio della notte, cerca e stringi la mano dell’iniziatore! diventa re. L’integrazione dei tuoi poteri sarà eterna; non piegherà innanzi al destino degli uomini e delle plebi intellettuali. Nell’oscurità densa non diventar pazzo d’orgoglio e mistico ― dici, e non disdire ― la parola magica, il verbum, è realtà, creazione.
È necessario. Il pontefice mago della magica Caldea conta la sua mistica istoria.
(O’ Thanatos, Anno I n. 6, giugno 1923, p. 6)
"Oggi, 26 giugno, mentre la Rivista è in macchina, ci perviene il seguito delle splendide note del Maestro su 13= LA MORTE. Siamo stati in attesa fino agli ultimi giorni, ma avvicinandosi la fine del mese (non avremmo potuto spedire le riviste in conto corrente superandosi tale data) e non sperando più di ricevere l’articolo, abbiamo dovuto impaginare, e ora non saremmo a tempo neanche a inviare e ricevere di ritorno le bozze di stampa. Chiediamo venia all’illustre Maestro, e di più ai lettori che attendono sempre con ansia di leggerne le profonde ed altissime pagine, rimettendone la pubblicazione al prossimo numero di luglio che uscirà nella prima quindicina del mese."
(O’Thanatos, Anno I n. 7, luglio 1923, pp. 4-13):
IX
Mamo Rosar Amru, colui che mai conobbe la morte, eternamente giovane e mitrato, ortodosso e templario commenta:
O miste, profano in attesa della sapienza, ricordati che Lucifero ti parla da ribelle ― il verbum è la parola del creatore ― nella notte oscura e profonda non troverai la mano dell’iniziatore pronta a stringere la tua, il tuo piccolo nume è in te, e te lo vieta. Io sono la legge del nostro tempio più grande, non sperare trionfi.
Quando in alto il cielo non era nominato, e la terra in basso non aveva ancora nome, le acque formavano una massa sola. L’Apsu primordiale e la tumultuosa Tiamat erano confusi in un solo amplesso.[23] I giuncheti non sapevano dove poggiare le tenere radici, e i densi boschetti di rose non erano ancora apparsi. Allora che nessun destino era fissato, furono creati gli dii.[24]
Quanti? Senza numero. Come le stelle. Fu la parola, l’aria, il soffio il loro primo corpo. Ea, sugli abissi delle acque, fu vento, alito, respiro, sospiro: così furono nominate le cose.
Per allietare il soggiorno degli dii furono creati gli uomini, Marduk volle così.
 La semenza dell’umanità è di Aruru; quando si propose di generare l’uomo, impastò l’argilla con le gocce del suo sangue, lo posò ad immagine degli dii, e ad essi preparò il culto. La creazione si compie ogni volta che piace agli dii e ogni dio può parteciparvi. Isthar presiede. Sei perciò, o miste, avvisato che il tuo destino è la schiavitù.[25]
La semenza dell’umanità è di Aruru; quando si propose di generare l’uomo, impastò l’argilla con le gocce del suo sangue, lo posò ad immagine degli dii, e ad essi preparò il culto. La creazione si compie ogni volta che piace agli dii e ogni dio può parteciparvi. Isthar presiede. Sei perciò, o miste, avvisato che il tuo destino è la schiavitù.[25]
Gli dii invisibili, che furono gli artefici del tuo essere, amano dilettarsi di te, esser serviti ed adorati da te. Sei perfetto per questo: l’egoismo è la tua più spietata virtù, è nelle tue fibre, nei tuoi nervi, nel tuo sangue, è il tuo sigillo e il tuo valore: non ti diletti alla guerra, con schietta ferocia di belva, e non onori i guerrieri in sepolture ricoperte di fiori? non hai il gusto raffinato dello spasimo altrui e della vendetta? ― Non hai avuto in dono un cervello a meandri, come opera di scultura, col quale hai trovato gli argomenti più sublimi, che Nebo, il sottilissimo tra i numi, non saprebbe rinvenire, per coronare di belle ragioni e pie tutti i misfatti del tuo orgoglio? Gli dii se ne dilettano allegri; ti irritano di tanto in tanto, quando tu rallenti i tuoi spettacoli pazzeschi.
La viltà, la volontà di prepotere, l’ambizione sfrenata, la lussuria, il tradimento non completano la tua superba immagine? non ti fanno vivere tragedie ad ogni sorgere e tramontare di luna?
Migliori? hai volontà di spogliarti della vecchia camicia insanguinata e assurgere ad una purità che ti illude nelle calme ore di pace oziosa, quando la fame e la cupidigia non ti tormentano? quando i più vili e paurosi ti intessono deliziose fiabe filosofiche, per addormentare in te il ricordo della leggiadra bestia che in eterno, sotto mille forme cangianti, tu permani? La tua storia, di ieri, come di oggi e di domani, non è scritta con un pennello insanguinato a larghe e profonde macchie vermiglie? non sei superlativamente cinico nella tua filosofia dei massacri? I dispotismi violenti e voluttuosi dell’Oriente non valgono le metafisiche della libertà dell’Occidente, in cui la schiavitù muta forma, e le idee, espresse con parole di convinzione, sono più gravi che le catene pesanti e rugginose degli antichi imperi? Credi che allora, attraverso i lontani millenni, non vissero i felici, i poveri, gli abietti, i violenti, i crudeli, i vili pacifici, i lussuriosi, i martiri, come ora, come domani, in città più superbe e ricche delle vostre grandi metropoli, con palagi e giardini insuperabili, con templi in cui l’oro e le gemme v’erano profusi? Babilonia non apriva al sole cocente la magnificenza artistica delle sue ricchezze e la seduzione dei suoi incanti? Lucifero, spirito della ribellione, allora, come oggi, motteggiava; ai suoi ispirati la lingua era tagliata o strappata con tenaglie roventi: agli offensori del diritto divino del comando, il carnefice svuotava le orbite, e le carni, a brandelli, erano date a divorare ai cani feroci del tempio di Nergal…
* * *
Lucifero, ironico, crudele, batte le palpebre in segno di assenso e, parodiando il pontefice difensore degli invisibili iddii, con voce cavernosa conchiude:
degli invisibili iddii, con voce cavernosa conchiude:
― O Miste, il verbo della tua schiavitù è fatto sangue e carne in te; il tuo destino è scritto.
Poi sogghigna e i suoi occhi scintillano, come diamanti puri, di luce viva, come di folgore.
X
Ai tempi di Roma, caldeo voleva dire mago. Erano i Caldei o i pretesi Caldei che facevano da indovini, astrologi e incantatori. Allora il professore Richet non aveva ancora inventata la parola metapsichica, che pare ai contemporanei più nobile della parola magia e più valorosa.
La Caldea era ritenuta allora la fucina di tutte le arti oscure della diavoleria mondiale. L’Egitto più sacerdotale. Babele, Ninive, Tiro palestre di stregoni, in cui ogni persona era uno strumento imprecatorio per comandare alle schiere innumere degli ulu, ululu e altri orribili abitatori dell’oceano dei malefizi.
Acutissimo lettore, quando cominciai a scrivere, trenta anni fa, di magia, per evocare l’antica arte dei tradizionali e fabulosi realizzatori di miracoli, tutti gli spiriti di Allan Kardec in Italia, tutti i lettori della propaganda di Denis, Delanne, Schuré e Flammarion si ribellarono come un uomo solo per questo nome vecchio che rimettevo in onore e richiamare l’attenzione dell’avanguardia sui poteri integrabili dell’organismo umano. Mutano i saggi col mutar dei tempi, e la parola magia si incontra, come le virgole, ad ogni dieci parole di orientalisti, folkloristi studiosi di popoli primitivi o creduti selvaggi. Me ne dissero di tante curiose che non parevano più spiriti di cristiani. Avevano dimenticato che il nostro comune amico Israele, tra Egitto e Babele aveva anche lui imbastita la magia giudaica; che Mosè invitò i maghi egizi a dar prova del loro potere e che questi gittarono nell’arena i loro serpenti di rame che divennero vivi e voraci e Mosè gittò il suo che tutti gli altri serpi distrusse; che Salomone re, oltre ad avere un laboratorio alchimico nella valle di Ophir per poco non fabbricò i diamanti a tonnellate per piacere alla bionda regina di Saba; che la Cabbala ebrea è il più fino di tutti i più sottili garbugli per tramandare ai posteri il Grande Arcano dell’Universo; che anche S. Pietro ebbe competenza nell’arte con Simone Mago e lo superò.
Ora, grazie alle missioni scientifiche, la magia è parola di buona lega, perché, scavando documenti che precedettero di tre millenni la gioconda apparizione dei Santi Padri, spiegano che imperi di lunghissima durata non ebbero ad impudicizia di reggere i loro popoli con commerci diabolici che tenevano luogo di minacce, di castighi e di flagelli.
I Caldei in quei tempi vivevano di divinità e di demoni. Carmi, scongiuri, imprecazioni, maledizioni ai mille diavoli che procuravano le infermità, come i microbi, o che attaccavano il corpo di colui che aveva allontanato il suo dio, o lo aveva irritato, o lo aveva tradito. Per divertire l’onorevole compagnia degli dii di Marduk, il babilonese doveva lottare coi casi strani della vita quotidiana, alimentati dalle avversità dei sette terribili geni del male, capaci di ogni cattiveria, mascherati in mille modi contro la pace dell’uomo in peccato; e dopo una vita non allegra, quando la morte lo colpiva, doveva lui stesso imporre paura ai vivi, che lo temevano peggio di ogni male, se la sua ombra non si placava nella sepoltura e un’offerta di cibarie non era pronta là a saziarlo di profumi culinari. Sceso il morto nel regno di Nergal, l’arallu, il luogo da cui non si fa ritorno, era costretto tra le tenebre più nere e la cenere più opprimente a vivervi in eterno. Nergal che alle buie regioni governava, le aveva circondate e rinchiuse di mura altissime, e dei diavoli più o meno caudati e cornuti tenevano in rispetto le ombre affinché non evadessero per tormentare i vivi.
Interpretazione profondamente dubbia e seccante, illogica della vita; se questa è la vera interpretazione dell’idea religiosa dei Caldei; io vi credo con approssimazione al terzo; il quadro, data la moderna psicologia,[26] che d’altronde non è neanche una scienza esatta, se pure è una scienza, da noi non è comprensibile nella sua malinconia di vita eterna, nell’oscuro inferno, dopo un brevissimo soggiorno in terra per sollazzare gli dii di Marduk. L’uomo, creato a immagine degli dei, o plasmato nella terra o dalle gocce di sangue di un dio, stillate una ad una nell’argilla o nel loto, aveva il quadro dell’esistenza dipinto a carbonella, coi grotteschi più orrificanti.
Doveva essere carina la vita terrena di un libero cittadino di Babele! certo nelle preghiere che quei sovrani onnipotenti, incarnazioni di Assur, il sempre vittorioso supremo guerriero, rivolgevano al dio o alle dee, domandavano per prima cosa una vita di lunghi giorni. L’arallu attendeva in una miscela scomposta tutti i mortali, re, sacerdoti, guerrieri, maghi, mercanti e schiavi, femmine libertine e sacerdotesse, medici e notai. Mi pare troppo! i soli guerrieri morti in guerra potevano essere serviti dalla sposa loro ― qualche altro poteva bere dell’acqua fresca ― il resto peggio dei più rognosi cani. Nergal feroce! Isthar, l’immortale Signora di bellezza ed’amore che corrispondeva un po’ alla Venere greca e alla Diana latina, se discende nell’arallu per ricercarvi il suo cicisbeo, è spogliata dei suoi veli e non può rimontare ai cieli senza un’aspersione di acqua di vita.[27]
Hanno un po’ ragione i metafisici e i teologi a bizantineggiare su questo luogo sozzo, detto inferno, in cui i detriti in decomposizione del superbo genere umano, vanno, se gli dii non fossero mutati, ad abitare in eterno. Tra tutte le cose relative dell’ineffabile Eistein, vi è una cosa assoluta, che non ha niente a vedere con le sue relatività: la paura dell’ignoto dopo la morte; la paura dell’ignoto e della morte che lo rappresenta nella forma più sintetica e più semplice: il dolore più acuto, per le nature che non hanno la disciplina filosofica di Seneca, è preferibile alla morte: nascere e morire; in latino oriri et mori; io nasco: orior; muoio: m-orior, mori possa esser sincope di moriri? quell’emme che precede orior (nasco) per dire muoio? misteri etimologici![28]
XI
Ireneo Filalete, in uno dei suoi famosi libri per cambiare i metalli ignobili in oro di coppella, avvisa, con la sua candida carità, che una volta riusciti a fare il prezioso metallo, bisogna star bene attenti a spenderlo e a mostrarlo; poiché il bargello, messo in guardia dalle voci del popolo che tu spendi e spandi oro di qualità finissima, verrà a domandarti se tale orefice o tal mercante di preziosi te l’ha venduto; e come che tu non potrai provarlo, ti metterà tra i ladri nella prigione perché tu non dirai che lo hai fabbricato col piombo e lo stagno e il rame e con particelle di ferro in limatura ― e se tu lo dicessi, ei non ti crederebbe e sollazzevole il giudice ti riderebbe in viso e ti direbbe: io non sono contadino che s’imbroglia alla fiera coi bagatti; io son filosofo e non bevo grosso come villano incolto.
La cosa è applicabile all’inferno, o al regno delle ombre in generale, che sia l’arallu caldeo o il purgatorio dei cristiani o il paradiso di S. Bonaventura. Il paradosso lo gitto nel pentolino di queste note come tale, come un’idea che passa per l’anticamera della cavità cranica, come una farfalla delle notti serene intorno al calice di un fiore in amore. Ed il lettore arguto capirà che io non parlo di Dante se dico che qualcuno avrà potuto benissimo visitar l’inferno e poi tornare in terra con la memoria delle cose viste, e saperle, e non poterle raccontare per non dire ai quattro angoli del firmamento che ha visto Astarte, la Domina, la Signora, la Grande Dama senza velo, mentre tutti non la vedono che vestita e velata, densamente oscura, con l’occhio scintillante di amore, perché Ella è, è stata e sarà come la madre sempiterna Vergine, la genitrice delle falangi di creature che popolano il bel pianeta a cui il cielo fa da ceruleo coverchio e le panzane vi spuntano, per autoseminagione, come la parietaria sui ruderi degli antichi edifizi. Voglio dire, mio acuto amico e critico, che il mondo scettico non incoraggerà mai qualcuno che nell’inferno vi è stato e che ne ricorda le vicende, a confessare e dire; come il bargello temuto dal Filalete, in un corpo solo i dottori della moderna Salamanca riderebbero e sputerebbero: ma che bubbola vai almanaccando? tu hai ricordo dell’altra vita, del buio della spelonca infernale? vatti a far guarire dal Morselli o da Leonardo Bianchi perché o sei matto o vuoi fare il matto; che sei tu Mosè o Enkidu o altro rivelatore?
Enkidu era il compagno di Gilgamesh,[29] in sogno aveva visto l’inferno, dove alti e potenti signori, scongiuratori, profeti e servi sono misti come in unica insalata russa, vestiti, come gli uccelli, di piume. Quando Enkidu muore davvero, Gilgamesh lo evoca per conoscere la legge della terra che egli ha visto.
Ed è una rivelazione tanto penosa, tanto triste pel vivente da farlo piangere. Com’è desiderabile l’immortalità! La pianta o l’erba della vita gli dii l’avevano riposta nell’Apsu, nell’abisso dei cieli e delle acque; Gilgamesh dopo un viaggio orribile, se ne impadronisce, ma un serpente gliela ruba. Pare un viaggio alchemico finito all’aceto; come la conquista del Vello d’oro, come le fatiche di Ercole armato di Clave, come Orfeo incantatore, come Cadmo alla conquista dell’Attica. I morti stanno male, anche sotto i monumenti della grande scultura, anche se i libri di Camille Flammarion dicono il contrario: meglio asino e vivo che dottore e morto. Che te ne pare, sottilissimo amico filosofo, che stai là a sorridere: non vi può essere ai giorni nostri, dopo cinquemila e più anni dalla storia di Enkidu e Gilgamesh, qualcuno che sia tornato dal paese dei morti ed ha paura di gridarlo forte per non rischiare un soggiorno nei manicomi della nostra grande Enotria, cara agli dii beoni di tutte le epoche? Il progresso è una favola?
XII
Apro una parentesi un po’ lunga e larga. Tanto queste note non sono materia di erudizione e le ho annunziate come semplici fiammelle per accendere qualche lucerna di Aladino.
Il lettore amico sappia che da che lo spiritismo è creato, da che ha fatto capolino nella società del secolo passato, avversato dalla scienza come cosa non provata ― i preti qui e là l’hanno tollerato o scomunicato ― come strumento di fede ha una lunga legione di credenti. Tutti hanno creduto da secoli ai morti, sotto una forma o sotto un’altra, non vi è popolo che non abbia esordito e continuato con la certezza che i morti, viventi nell’ombra, ci guardano, ci vedono, ci ispirano, e all’occorrenza ci vengono in sogno per indicarci un destino imminente o un terno al lotto; però lo spiritismo, come l’occultismo, come il teosofismo, non ha avuto un critico demolitore, polemico, a conclusioni metafisiche ― ma dopo la guerra (che cosa non ha fatto la guerra!) la musica è cambiata.
 Leggo L’Erreur spirite di René Guénon,[30] autore di un altro volume, Le Théosophisme,[31] apparso qualche anno fa. Un libro che esce dall’ordinario questo qua. Non so dell’autore nessuna notizia: Le Théosophisme mi dette l’impressione di una polemica culturale, come se un allievo della Compagnia religiosa tale volesse riveder le bucce ad una congrega pseudo religiosa, come il sottotitolo chiama la fondazione del Colonnello Olcott e della Signora Blavatsky, in molti punti, con veste più dignitosa, un po’ troppo saporito. Ma L’Erreur spirite, testé uscito, ha un altro valore. Bisogna leggerlo perché è un avversario di misura rispettabile, perché senza confessare ancora dove miri, fa un po’ l’Attila re degli Unni per dare addosso prima allo spiritismo e poi all’occultismo e alla metapsichica; s’intende spiritismo francese, occultismo francese, metapsichismo francese, con qualche notizia dell’Inghilterra: il resto del mondo non conta; in Italia si coltivano le sole carote che ci vengono seminate dai libri francesi; già ho fatto capire più sopra che quando scrissi l’Avviamento alla scienza dei magi, se non avessi mostrato la più tranquilla tolleranza per tutto il diluvio dei libri di spiritualismo che Parigi ci faceva digerire, non avrei trovato neanche un lettore che mi avesse studiato. La libreria francese contiene ora una completa collezione di autori che hanno pubblicato volumi su tutti gli arcani. E che di più dovrebbero far testo nelle interpretazioni e nella veste romantica con la quale sono presentati. Dopo Éliphas Lévi, si parla ora della Haute Magie, come se questa avesse dei cultori insigni a Parigi da esibire al mondo, per modelli del genere. Tanto carina una inchiesta sulla Haute Magie au 1923 pubblicata ultimamente dalla Revue Mondiale. Giacché io scrivo queste note ridendo, per non appesantire il lugubre argomento della morte, devo confessare che questa Haute etc. mi ha messo di ottimo umore, e, senza essere uno psicometro, mi è parso di vedere, di là del paravento, ridere anche il mio amico ebraizzato Éliphas, serio serio, con un moccichino che soffiando il naso, nascondeva la bocca ridente.
Leggo L’Erreur spirite di René Guénon,[30] autore di un altro volume, Le Théosophisme,[31] apparso qualche anno fa. Un libro che esce dall’ordinario questo qua. Non so dell’autore nessuna notizia: Le Théosophisme mi dette l’impressione di una polemica culturale, come se un allievo della Compagnia religiosa tale volesse riveder le bucce ad una congrega pseudo religiosa, come il sottotitolo chiama la fondazione del Colonnello Olcott e della Signora Blavatsky, in molti punti, con veste più dignitosa, un po’ troppo saporito. Ma L’Erreur spirite, testé uscito, ha un altro valore. Bisogna leggerlo perché è un avversario di misura rispettabile, perché senza confessare ancora dove miri, fa un po’ l’Attila re degli Unni per dare addosso prima allo spiritismo e poi all’occultismo e alla metapsichica; s’intende spiritismo francese, occultismo francese, metapsichismo francese, con qualche notizia dell’Inghilterra: il resto del mondo non conta; in Italia si coltivano le sole carote che ci vengono seminate dai libri francesi; già ho fatto capire più sopra che quando scrissi l’Avviamento alla scienza dei magi, se non avessi mostrato la più tranquilla tolleranza per tutto il diluvio dei libri di spiritualismo che Parigi ci faceva digerire, non avrei trovato neanche un lettore che mi avesse studiato. La libreria francese contiene ora una completa collezione di autori che hanno pubblicato volumi su tutti gli arcani. E che di più dovrebbero far testo nelle interpretazioni e nella veste romantica con la quale sono presentati. Dopo Éliphas Lévi, si parla ora della Haute Magie, come se questa avesse dei cultori insigni a Parigi da esibire al mondo, per modelli del genere. Tanto carina una inchiesta sulla Haute Magie au 1923 pubblicata ultimamente dalla Revue Mondiale. Giacché io scrivo queste note ridendo, per non appesantire il lugubre argomento della morte, devo confessare che questa Haute etc. mi ha messo di ottimo umore, e, senza essere uno psicometro, mi è parso di vedere, di là del paravento, ridere anche il mio amico ebraizzato Éliphas, serio serio, con un moccichino che soffiando il naso, nascondeva la bocca ridente.
Ma ritorniamo a L’Erreur.
Il Guénon, siccome io non sto all’altezza di comprendere bene tutto quello che i filosofi dicono, mi pare che qui e là si duole che la metafisica pura può farlo difficilmente capire; qui e là fa intendere che la magia la conosce come io la mia saccoccia, ed infatti spesso colpisce giusto e annota, en passant, che in oriente certe cose si fanno coi piedi: ciò che farebbe supporre che ha sorpassato il Tibet ed ha raggiunto il culmine dell’Everest; l’Occidente, con le sue macchine, i suoi oli lubrificanti, gli enormi impianti idroelettrici, non vale tre baiocchi di Pio IX. Ma come èpensato e scritto il libro, merita di esser letto. Dimostra che gli spiriti dei morti, filosoficamente, non possano affatto comunicare coi vivi, perché, per un milione di perché, la disgregazione del morto è affare assodato. Non esistendo il perispirito e tanto meno il suo sinonimo il corpo astrale degli occultisti, un granello va al nord, cinque vanno all’occidente e diciotto ad oriente; il resto di ciccia e calcari va sotto terra, per restituire ad essa gli elementi che ci ha prestato.
La dialettica, il senso critico, il buon senso di demolire per conto di non so chi, mettendo innanzi che lo spiritismo è dannoso all’appetito e all’equilibrio mentale, rappresentano una carica folta, serrata, in pagine fitte e saporose, e ammirevole (senza celia), che trascineranno molti lettori fino all’ultima pagina del libro, anche non arrivando a comprendere, come me, quella purissima metafisica per la quale non tutti sono costruiti secondo l’arte di Ponzio Pilato.
Determinata l’impossibilità che uno spirito di defunto possa esistere nella sua personalità complessa e completa, tale da poter dire: io mi sento e sono il tal dei tali; e quindi, precisando che non è possibile per questa ragione la comunicazione tra morti e vivi, l’autore viene alla impossibilità che una reincarnazione vi possa essere, neanche pei Messia della maniera ebrea o di altra razza. La reincarnazione è idea moderna, come lo spiritismo: gli antichi non ne sapevano niente. Perfino gli orientalisti di oggi sono suggestionati dall’idea della reincarnazione e interpretano documenti antichissimi con idee contemporanee, passate dallo spiritismo kardechiano al teosofismo della Besant e a certi occultisti francesi e da questi, varcata la Manica, in Inghilterra, dove le comunicazioni degli spiriti pare che dicano il contrario di quelle francesi. Il Guénon ha dimenticato che l’idea della reincarnazione è prepitagorica e che Diogene Laerzio non è autore del secolo XIX.
Insomma, acuto amico lettore, bisogna che scoviamo il messere che è ritornato dall’inferno e non ha ancora aperto bocca per dirimere questioni così allegre.
XIII
Un guaio se la scienza delle Università si occupa dello spirito umano; più grosso guaio se se ne occupano i filosofi. Metafisica e sperimentalismo mi paiono due cose temibili per la pace dei morti. Quanto pagherei per sapere dov’è questo sornione che è stato all’inferno, a vedervi i morti, e se è ritornato vivo e in pieno cosciente ricordo, in completa integrità mentale.
Lucifero sorride ironico, come le stelle che guardano da lassù, cielo azzurro, profondamente sereno e misterioso, cielo italico pieno dei profumi dei nostri giardini, le nostre piccole metafisiche.
Lucifero parla, ammiccando con l’occhio, come fanno, scintillando, gli astri del firmamento: ― Chi vuoi che sia dal regno dei morti tornato e lo venga a dire a te che lo racconti ai porri scientifici della tua bottega? ― vuoi tu interrogare un matto? non sono i dementi i più freschi arrivati dall’oscura valle ove gli dei, i geni e i morti eroi giocano al poker per passare il tempo? il pazzodei tarocchi non ha peli alla lingua ― evocalo; vuoi che ti aiuti?
Lucifero agita le braccia come due mulinelli e dirige la sua destra mano verso l’angolo più buio, come vi scagliasse un pizzico di pepe: si sente abbaiare un cane, poi il matto appare, roteando anche lui il bastone da pellegrino:
scagliasse un pizzico di pepe: si sente abbaiare un cane, poi il matto appare, roteando anche lui il bastone da pellegrino:
― Oh! vecchi amici di seminario, perché mi volete? perché mi chiamate? ero dietro a seguire un corteo funebre; una donna bellissima è morta e la gente la piange e ne fa le lodi; stupida gente! s’ella avesse vissuto ancora qualche anno, sarebbe diventata brutta come la più affumicata pignatta: quelli che viva non seppero farla felice, la piangono ora che è felice…
Mentre il pazzo parlava, dall’angolo buio, si staccava una massa di curiosi che lo avevano seguito: nella possente evocazione a molinelli magnetici dell’ironico Lucifero, per poco col matto non fu attirato a noi dinanzi il funebre corteo della bella: il pubblico rideva.
Lucifero interroga:
― E che fa la morta? è più felice che viva? vogliamo sapere che fannoi morti, che cosa è la morte… un matto patentato come te, se hai visto e se sai, non avrà paura dei critici e della metafisica, dell’università o del rogo! che fanno i morti? che cosa è la morte?
Il matto rivolse al suo seguito un risolino beota, uno di quei sogghigni metafisici che non s’inventano, e s’accinse alla predicazione.
Tutti restarono sospesi, in silenzio, aspettando che egli dicesse. Anche il cane tacque nell’attesa ansiosa. Solo una stella del firmamento, ironica, rifletteva il malizioso ritmo del portatore di luce.
*(Tratto dalla rivista O’Thanatos, ristampa integrale Edizioni Rebis, 1990).
[1] Smith, Finot e Mapp-si, citato dal Weber. [?]
[2] J. Frumusan, La cure de rajeunissement. Le devoir, la possibilité et les moyens, Paris, 1922.
[3] [Victor Darwin Lespinasse (1878-1946)]
[4] C. Lancelin, La vie posthume, Paris, Durville, 1922.
[5] Velivoli, automobili, ferrovie, telegrafi e telefoni d’ogni sorta.
[6] Sono le tavole degli arcani maggiori dei tarocchi, figure filosofiche che servono ad aprire gli occhi ai quasi ciechi.
[7] Le formole magiche, specie quelle che appartengono ai riti mortuari, sono quasi tutte in possesso della non breve falange degli studiosi, ma le parole onnipotenti non hanno valore se non pronunziate con voce giusta e intonazione propria, vale a dire che nella bocca dei volgari non hanno valore.
[8] Ovidio chiamò la Morte nutrix maxima curarum, la grande nutrice degli affanni, e Varrone disse nox proveniente da nocere, perché nelle ore senza luce il dolore e le pene sono più acute. Catullo chiamò la Morte perpetua nox e Ovidio l’ignoranza nox animi.
[9] Dà agli uomini il secreto per diventare immortali? Ricordarsi di questo quando parlerò della morte nell’Alchimia. Delle 14 parti Iside non ne trovò che 13. La quattordicesima, il fallo, era stata mangiata da un pesce.
[10] Quella che giudicò Galileo e voleva impedire a Colombo la scoperta dell’America, era scienza officiale a quei tempi.
[11] Magicis etiam coenis eum initiaverat. Quintilianus.
[12] [“conventi dilettevoli mpage,” nel testo a stampa]
[13] Joshua Trees, Marshall, Boston, 1922.
[14] [Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño, 1635.]
[15] La poesia della prosaica America di oggi concepisce, con due tendenze (A. Davison Ficke e gli imitatori di W. Whitman), la visione della vita. La vita è niente e i sogni sono tutto, dice il primo. La realtà è il più bello dei sogni, cantano i secondi. Cfr. Jean Catel in: Mercure de France n. 598, Paris, maggio 1923, pp. 236-243.
[16] Citato nell’introduzione ad un gruppo di scrittori del XVIII secolo, da Letour. [?]
[17] Prometeo, latino Prometheus, greco IIρομηθεύς, contiene la radice math o med che è assonante in tutti i vocaboli che contengono l’idea concreta della ragione e della misura μεδ-ομαι, penso, cogito; Med-eri, tener cura, curare, medicare. Mathesis; mathe-maticus; re-med-ium.
Era il saggio, meditante, prudente e audace. Il sapiente di oggi e di tutti i tempi, non iniziato, ma civilizzatore, il grande e il semidio vivente.
[18] «Minerva dicta, quod bene moneat. Hanc enim pagani pro sapientia ponebant». Sesto Pompeo Festo, De verborum significatione, XI.
[19] Eschilo, Atto II. Cito a ricordo.
[20] Ora potrebbe aggiungere: ho insegnato loro la fabbricazione dei tossici e dei microbi applicati alla guerra, i sottomarini, il volo nei cieli. Ma è da supporsi benignamente che il male fosse quaggiù mandato dalla malizia degli dei, nello scatolo portato in dono di nozze dalla signorina Pandora.
[21] Anche qui vedi: pir il fuoco, piramide forma della fiamma dell’olocausto che monta ai cieli. Prometeo trasformò l’olocausto (holos, intero, e kaiein, bruciare) che era costituito dalla consumazione per mezzo del fuoco dell’intera vittima, in consumazione parziale delle sole ossa, distribuendo la carne ai sacrificatori. Questo dovette parere grande offesa a Giove, che ingannato dalle apparenze, aveva scelto per offerta agli dei la cremazione delle ossa.
[22] Le due colonne del tempio J e B, nel binomio dei due contrari di luce e di ombra, sono inamovibili. La visione non è possibile se la luce non è temperata dall’ombra. Il bene esiste in rapporto del male; il bello, del brutto; il dolce, dell’amaro; l’uomo non può confondere i termini in contraddizione; non può neanche pensarli uniti. Appresso ne parleremo, nella concezione di un regno degli spiriti alla maniera dei mistici.
[23] P. Dhorme,Choix de textes religieux assyro-babyloniens, Paris, 1907, pp. 3-5. L’Apsu era l’abisso delle acque sulle quali Ea signoreggiava (G. Contenau, La civilisation assyro-babylonienne, Paris, 1922). Il Delaporte(La Mésopotamie,les civilisations babylonienne et assyrienne, Paris, 1923) traduce Apsu per l’oceano delle acque dolci che circonda la terra e Tiamat il mare, l’oceano delle acque salse.
[24] Il lettore acuto legga bene: il cielo e la terra e gli dii non erano nominati, cioè non avevano nome, la creazione non era avvenuta perché la parola, che indicava la cosa, il nome, il verbo creatore, non era stato pronunziato.
[25] Isthar possedeva tutte le facce, bellezza, amore casto, lascivo, crudele, materno. In Assiria perfino dea guerriera, perché alla donna fino dai più lontani tempi fu riconosciuto quello spirito bellicoso che la rende così amabile.
[26] La cavità cranica dell’uomo, in quella anatomia ineffabile dei poeti, è una grotta a stalattiti e stalagmiti che variano di lunghezza e grossezza in ogni individuo. La psiche è una farfallina che vi abita e vi si diverte. Gli uomini sapienti spesso non vanno d’accordo perché l’esuberanza stalattitica degli uni non coincide con la povertà stalagmitica degli altri. Di questa roba se ne avvantaggia il filosofo e son venute fuori tante dottrine psicologiche che aspettano di diventare adulte e laudabili.
[27] Che cosa sia quest’acqua di vita nessun assiriologo ha potuto capire.
[28] Ma anche nella ricerca delle etimologie delle parole di senso nascosto, specie se riguardano cose attinenti ai misteri religiosi o alle antiche misticologie settarie, bisogna andar cauti. Ed in greco βροτός mortale e άμβροτος immortale, άμβρσια è bevanda che bevono gli dei, o nettare che dà l’immortalità?
[29] L. Delaporte, op. cit.
[30] Marcel Rivière, Paris, 1923.
[31] [Le Théosophisme, histoire d’une pseudo-religion, Nouvelle Librairie nationale, Paris, 1921.]