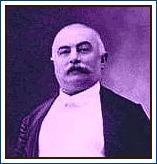La questione dell’interdizione pitagorica delle fave non costituisce certamente un grosso problema di filosofia e neppure di storia della filosofia, ma soltanto un problema ben circoscritto che desta per altro vivo interesse in una cerchia abbastanza larga di studiosi, meravigliati ed incuriositi nel constatare che anche a proposito di un argomento così preciso e ristretto gli specialisti del pitagoreismo non siano in grado di pervenire ad una conclusione concorde e soddisfacente. Augusto Rostagni nel suo Il Verbo di Pitagora si limita ad accennare alla “spinosa questione delle fave” (A. Rostagni, Il Verbo di Pitagora, Torino, 1924, p. 121, nota), e non dice altro.Se ne occupano invece, ma senza poter giungere ad alcuna conclusione: Chaignet (Anthelme Édouard Chaignet, Pythagore et la Philosophie pythagoricienne, Paris, 1874, 2ª ed.) ed il Delatte (Armand Delatte, Études sur la Littérature Pythagoricienne, Paris, 1915).
La questione dell’interdizione pitagorica delle fave non costituisce certamente un grosso problema di filosofia e neppure di storia della filosofia, ma soltanto un problema ben circoscritto che desta per altro vivo interesse in una cerchia abbastanza larga di studiosi, meravigliati ed incuriositi nel constatare che anche a proposito di un argomento così preciso e ristretto gli specialisti del pitagoreismo non siano in grado di pervenire ad una conclusione concorde e soddisfacente. Augusto Rostagni nel suo Il Verbo di Pitagora si limita ad accennare alla “spinosa questione delle fave” (A. Rostagni, Il Verbo di Pitagora, Torino, 1924, p. 121, nota), e non dice altro.Se ne occupano invece, ma senza poter giungere ad alcuna conclusione: Chaignet (Anthelme Édouard Chaignet, Pythagore et la Philosophie pythagoricienne, Paris, 1874, 2ª ed.) ed il Delatte (Armand Delatte, Études sur la Littérature Pythagoricienne, Paris, 1915).
Gli scrittori antichi, da Aristotele sino ai neo pitagorici dei primi secoli dell’era volgare, concordano in generale nell’affermare che Pitagora vietava ai suoi discepoli il mangiare le fave, ma dissentono nello spiegare le ragioni del divieto. Aristosseno (cfr. Aulo Gellio, IV, 11) afferma invece che la fava era un alimento raccomandato ed impiegato frequentemente da Pitagora, che lo trovava digestivo e lassativo. Come conciliare questa categorica asserzione di Aristosseno con la tradizione generale sopra la proibizione delle fave; e quale, tra le tante, la spiegazione plausibile sopra l’interdizione pitagorica?
L’asserzione di Aristosseno è inconciliabile con la tradizione generale solo se si suppone che l’una e l’altra si riferiscano a tutti, abbiano cioè carattere generale; scompare invece l’inconciliabilità se si ammette che l’interdizione pitagorica si riferisse solo ai discepoli od anche ad una parte dei discepoli della scuola. Quanto alle ragioni addotte sino dai tempi antichi per giustificare il divieto, esse sono parecchie, discordi, e poco o punto soddisfacenti. Si trovano riportate nello Chaignet e dal Delatte ad eccezione di una sola, proprio quella che, come riteniamo, è la giusta.
Secondo lo Chaignet (Chaignet, I, 122) l’interdizione delle fave era comune agli orfici ed ai pitagorici. Secondo Diogene Laerzio (VIII, 34) Aristotele riconosce che il precetto dell’interdizione è pitagorico; e nei rimasugli di storia del pitagoreismo di Heraclide Pontico (Lyd., De mensibus, IV, 29) si trova il seguente verso sopra l’interdizione delle fave: «’Isón toi kyàmous te phageîn kephalàs te tokéon».
Heraclide non designa il nome del poeta da cui è preso il verso; parecchi autori citano questo verso o vi fanno allusione esponendo le ragioni che secondo loro hanno determinato il divieto delle fave; ed in Luciano (Dial. Mortu., 20, 3) Pitagora stesso pronunzia una frase simile al verso su riportato. Secondo il Delatte i pitagorici contemporanei di Aristotele non comprendevano più molto bene le ragioni d’essere di questa interdizione. Comunque, Aristotele presenta ed esamina varie ragioni che sembrano prese in prestito dai vari pitagorici.
Vediamole:
1) Il divieto è determinato dal fatto che le fave assomigliano alle parti vergognose (pudendae); così trovasi in Aulo Gellio (IV, 11) ed in Luciano (Vit. auct., 6). Questa interpretazione concorda col significato del verso greco su riportato. Il riconoscimento di questa somiglianza si può constatare ancor oggi in alcune forme eufemistiche dialettali italiane, senza per altro indurre gli abitanti di quelle regioni ad astenersi dal cibarsi di fave.
2) Le fave sono simili alle porte dell’inferno, perché la fava è la sola pianta priva di nodi (Diogene Laer., VIII, 34). Secondo il Delatte questo orrore pitagorico per le fave, così motivato, si spiega mediante un passo di Porfirio (De antro Nymph., 9); Porfirio, commentando un’antica leggenda dell’antro delle ninfe nell’Odissea, ricorda che gli antichi teologi paragonavano le anime pure e virtuose alle api. Le api, infatti, non si posano mai sulle fave, perché esse simboleggiano il ritorno immediato delle anime alla vita terrestre; la ragione di questo simbolo è che la fava è la sola pianta il cui gambo è privo di nodi. Per comprendere questo paragone bisogna pensare che il desiderio di una rapida reincorporazione è per l’anima l’indizio di una vita corrotta (Plut., De sera numinis vindicta, 22). È evidente, prosegue il Delatte, che la spiegazione originale della funzione delle fave nella metempsicosi non comportava alcun simbolismo. Il rapporto era puramente materiale: l’anima trovava nelle fave un mezzo facile per uscire dall’Ade, perché le anime potevano passare per lo stelo delle fave senza che esso si opponesse in alcun modo alla loro ascensione. Questa concezione, dice il Delatte, è abbastanza grossolana e primitiva per essere antica. Inoltre, se il ritorno alla vita terrestre avviene per mezzo delle fave esse contengono le anime dei morti, e si comprende che sia un sacrilegio il mangiarle, come lo giudica un commentatore di Omero di cui è conservata notizia da Eustato (ad Iliadem, p. 948) e negli scolii (Townleyana, Iliade N. 589).
Così pure Plinio (N. H., XVIII, 18) spiega in questo modo l’interdizione: quoniam mortuorum animae sint in ea (cfr. pure Plut., quae rom., 95, e Festo, s. v., faba). A questo concetto si collega una delle ragioni invocate da Timeo, che le fave partecipano più di ogni altra pianta al principio spirituale (Diog. Laer., VIII, 24).
Infine da questa stessa credenza hanno origine le storie di Heraclide Pontico (in Lyd., De mensibus, 24) e di Antonio Diogene (ibidem et Porph., V, 1, 44) ed Hyppol. (adv. haeres., I, 2, 14) sopra le metamorfosi magiche di una fava deposta in un vaso e ricoperta di terra.
3) Perché essa è dannosa. Le fave infatti avevano la reputazione di far perire le altre piante e di rendere sterili il terreno e gli animali. Questo motivo viene spiegato da Theophrasto (De causa plantar., V, 15, 1), da Clemente Alessandrino (Stro., III, 24) e da Eustato (ad Iliadem, p. 948).
4) Per motivi oligarchici (Luciano, Vita auctor, 6, e Giamblico, V, p. 260). Le fave, infatti, sono il simbolo della democrazia, perché servono a tirare a sorte i magistrati; astenersene è dimostrare sentimenti aristocratici ed oligarchici. Questo motivo è stato sfruttato dalla fonte comune cui attingono Androcide ed Anassimandro per trarre un senso simbolico da questa formula.
Aristotele crede che la regola dell’astinenza era ancora osservata alla lettera ai suoi tempi. Secondo una tradizione la formula significa che non bisogna prendere parte alla politica (Hyppoli., VI, 27, e Ps. Plut., Lib. ed., 17). Secondo un’altra tradizione il precetto va inteso in un altro senso in Arsenio (viol., p. 415) ed Apostolius (XV, 11); cioè le fave di cui si tratta sono quelle che servono ai giudici per rendere le sentenze, ed il precetto significa: non vivere degli introiti che possono portare le fave (del tribunale), cioè non lasciarti corrompere nel rendere giustizia.
Infine lo Chaignet esprime l’opinione che si tratti di una pratica superstiziosa destinata a fortificare il sentimento religioso con una disciplina materiale, senza attribuire alcuna ragione alla scelta propria di questa particolare interdizione.
Tutte queste spiegazioni ci sembra che attestino l’effettiva esistenza ed arcaicità della interdizione delle fave, ma anche ed in pari tempo l’ignoranza egualmente arcaica della vera ragione della proibizione. Se non fosse stato anche allora un mistero, tutti questi scrittori e commentatori avrebbero fedelmente riferita la spiegazione senza essere costretti a fare delle congetture ed esprimere le loro opinioni in proposito. La spiegazione che vede nelle fave le porte dell’Ade, perché mediante le fave le anime possono agevolmente risalire alla superficie della terra e quindi reincorporarsi, trovava e trova naturalmente consenzienti i credenti nella reincarnazione e coloro che ritengono che Pitagora insegnasse la metempsicosi. Ci sembra per altro che questa idea del ritorno alla superficie della terra mediante le fave sia un’idea tanto primitiva e grossolana da potere essere fabbricata od accettata dall’ingenuo fanatismo religioso popolare, ma che non la si possa attribuire a Pitagora senza diminuirlo.
Quanto a noi, già da tempo avevamo trovata la vera ragione di questa interdizione nel fatto che, dopo aver mangiato delle fave, la pratica della meditazione ci era notevolmente disturbata. Constatato nettamente il fatto inatteso, era naturale ricordare l’interdizione pitagorica delle fave e riconoscere nel fatto sperimentale la semplice spiegazione del divieto pitagorico.
 Ci siamo sinora astenuti dal parlarne per due ragioni: primo, perché il regime fascista ci ha ridotto per venti anni al silenzio; secondo, perché la nostra spiegazione sperimentale sembrava non trovare nessun conforto, neppure indiretto, nella letteratura pitagorica antica e tra gli studiosi moderni di storia e filosofia pitagorica. Ma la traccia esiste, sebbene non sia riportata dagli specialisti di studi pitagorici, ivi compresi lo Chaignet, il Delatte ed il Rostagni. L’abbiamo trovata in uno scritto di un farmacista sulle piante divinatorie considerate specialmente dal punto di vista medico.
Ci siamo sinora astenuti dal parlarne per due ragioni: primo, perché il regime fascista ci ha ridotto per venti anni al silenzio; secondo, perché la nostra spiegazione sperimentale sembrava non trovare nessun conforto, neppure indiretto, nella letteratura pitagorica antica e tra gli studiosi moderni di storia e filosofia pitagorica. Ma la traccia esiste, sebbene non sia riportata dagli specialisti di studi pitagorici, ivi compresi lo Chaignet, il Delatte ed il Rostagni. L’abbiamo trovata in uno scritto di un farmacista sulle piante divinatorie considerate specialmente dal punto di vista medico.
Ecco quanto scrive il Rouhier, dottore in farmacia (A. Rouhier, Dr. en Pharmacie, Les plantes divinatoires, Paris, 1927, pp. 9-10): «Dal punto di vista solamente alimentare permettetemi di ricordarvi la famosa interdizione che Pitagora aveva lanciata per i discepoli della sua scuola esoterica contro la fava. Egli invocava la ragione che, composto dei medesimi elementi dell’uomo, questo vegetale poteva diventare colla trasmigrazione la sede dell’anima umana. Orazio, che non era che un poeta, si è beffato di questa storia della fava! Orazio ha avuto torto, Pitagora n’était pas un sot e noi ignoriamo le ragioni per le quali è stato obbligato a mascherare il proprio pensiero! La facoltà metagnomica è fragile, incerta, balbuziente in molti petits-voyants ed anche talora nei grandi veggenti. Perché cause minime, o certe sostanze, non basterebbero a turbarla, ad attenuarla, od al contrario a farla nascere ed a svilupparla?»
Cicerone, prosegue il Rouhier, più avveduto di Orazio, ha sentito che vi era altra cosa sotto la ragione interdicente di Pitagora, e nel suo libro Della Divinazione pretende che i pitagorici si astenevano dalle fave «perché, irritando l’intelletto, la fava turbava la tranquillità dell’animo ed impediva ai sogni divinatori di manifestarsi».
Il Rouhier non dà le citazioni; ma il passo di Orazio si trova nei Sermones (II, 6, 63) e quello di Cicerone si trova nel De Divinatione (Libro I, cap. XXX). Il passo di Cicerone è il seguente: «Jubel igitur Plato, sic ad somnum proficisci corporis affecti, ut nihil fit, quod errorem animis perturbationemque afferat. Ex quo etiam Pythagoricis interdictum putatur ne faba vescerentur, quod habet inflationem magam in cibis, tranquillitatis mentis, quaerenti vera, contrariam. Cum est somno evocatus animus, a societate et a contagione corporis tum meminit praeteritorum, praesentia cernit, futura praevidet».
Cicerone dunque dice che si ritiene (non dice da chi) che la ragione dell’interdizione delle fave stia nel fatto che essa provoca una inflazione, che è contraria alla tranquillità della mente che cerca il vero: poiché, aggiunge di suo o riporta, quando il corpo nel sonno è evocato dalla società e dal contagio del corpo, allora si ricorda delle cose passate, vede le cose presenti e prevede quelle future.
Cicerone a vero dire non si pronuncia, in questo passo del De Divinatione, in merito alla spiegazione della interdizione delle fave, e si limita a riferire una opinione senza dire da chi l’abbia saputa e chi la sostenga. Ma in un altro passo, e precisamente nel Libro II, cap. 58, dice quel che ne pensa, e se il Rouhier lo avesse tenuto presente non avrebbe certo contrapposto il «buon senso» dell’avvocato romano all’incompetenza del poeta. Dice infatti Cicerone che i pitagorici vogliono che ci si astenga dal mangiare fave «come se quel cibo gonfiasse il cervello e non già il ventre! Ma non veggo assurdità che non esca di bocca a qualche filosofo!...». Però non soltanto ai filosofi possono uscire di bocca delle assurdità; può capitare anche alle male lingue che credono di confutare un argomento con una spiritosaggine. Non si tratta di vedere se la gonfiezza del ventre causi necessariamente il turbamento della mente, perché è notorio che i fagioli e le castagne causano l’inflazione del ventre senza che ne seguano conseguenze spirituali oltre al salire al cielo, come diceva Gandolin, dell’anima di un fagiolo. Si tratta di vedere se l’ingestione di un cibo o di una sostanza (gonfi o non gonfi il ventre) può causare disturbi od effetti sopra il funzionamento del cervello e quindi della mente. Ed è certo che il vino dà l’ebbrezza, e Platone riferisce che i coribanti si procuravano una speciale ebbrezza mediante i fumi della canapa.
Noi sappiamo che la cannabis indica, l’oppio, la cocaina, il peyotl… esercitano un’azione sulle funzioni cerebrali e sulla mente; quindi non si può escludere con un motto di spirito che possa succedere qualche cosa di analogo anche con le fave; solo l’esperienza non preconcetta può dire qualche cosa in proposito, ed è appunto quanto ci è accaduto in modo inatteso e senza prevenzioni. Abbiamo semplicemente constatato un «effetto», come oggi si usa dire, e, supponendo che esistano e siano esistiti altri organismi umani non in tutto dissimili, abbiamo osservato che questo fatto può benissimo spiegare e giustificare per essi l’inibizione delle fave, specialmente nel caso in cui sia opportuno che la mente non venga turbata. La ragione di questa inibizione pitagorica non si conosce con sicurezza; ne vengono date molte e discordanti e poco plausibili. Gli studiosi di pitagoreismo non riportano la nostra spiegazione, ma essa compare anche nell’antica letteratura, come mostra il passo di Cicerone il quale afferma che si ritiene (putatur) che l’ingestione delle fave determini nella mente l’inquietudine. Si tratta di vedere se è vero o no, e non di vedere se l’inquietudine mentale sia conseguente alla gonfiezza del cervello o del ventre. Anche se la gonfiezza del ventre accompagnasse o determinasse l’azione sopra la mente, non è giusto dire ai filosofi cui Cicerone allude che l’ingestione delle fave gonfia il cervello e determina quindi il turbamento della mente. Questa assurdità non è stata detta dai filosofi pitagorici, e Cicerone l’attribuisce loro per poterla facilmente confutare con una spiritosaggine. Del resto Cicerone non dice affatto di riferirsi agli antichi scrittori pitagorici, e può darsi benissimo, dato che la spiegazione non si ritrova nella letteratura pitagorica, che egli l’abbia attinta da quei gruppi di pitagorici romani che in quei tempi o poco dopo compaiono attorno a Nigidio Figulo, o dai predecessori di quelli che componevano in numero di 28 la confraternita pitagorica che si radunava nella basilica pitagorica sotterranea presso la Porta Maggiore. Il 28 è un numero perfetto anche nell’accezione moderna della parola, derivata pari pari da quella antica, cioè il 28 è un numero che è uguale alla somma dei suoi divisori escluso il numero stesso. Vi è però un’altra ragione che fa del 28 un numero perfetto, prendendo la parola perfezione nel senso greco etimologico della parola, che è poi anche il senso della perfezione secondo Pitagora, Aristotele e Dante, ossia di compiutezza. Esso è perfetto come lo sono il 4 e il 10: il quattro è il primo numero dopo la triade dei primi tre numeri, il 10 è il primo numero dopo le prime tre terne di numeri (ed anche perché nel sistema di numerazione decimale è la prima unità di ordine superiore e perché è legato e identificato al 4 nella relazione della tetractis: 1 + 2 + 3 + 4 = 10), ed il 28 è il primo numero che segue la terna delle tre enneadi; inoltre il suo pitmene, resto della divisione per 9, è l’unità.
esistiti altri organismi umani non in tutto dissimili, abbiamo osservato che questo fatto può benissimo spiegare e giustificare per essi l’inibizione delle fave, specialmente nel caso in cui sia opportuno che la mente non venga turbata. La ragione di questa inibizione pitagorica non si conosce con sicurezza; ne vengono date molte e discordanti e poco plausibili. Gli studiosi di pitagoreismo non riportano la nostra spiegazione, ma essa compare anche nell’antica letteratura, come mostra il passo di Cicerone il quale afferma che si ritiene (putatur) che l’ingestione delle fave determini nella mente l’inquietudine. Si tratta di vedere se è vero o no, e non di vedere se l’inquietudine mentale sia conseguente alla gonfiezza del cervello o del ventre. Anche se la gonfiezza del ventre accompagnasse o determinasse l’azione sopra la mente, non è giusto dire ai filosofi cui Cicerone allude che l’ingestione delle fave gonfia il cervello e determina quindi il turbamento della mente. Questa assurdità non è stata detta dai filosofi pitagorici, e Cicerone l’attribuisce loro per poterla facilmente confutare con una spiritosaggine. Del resto Cicerone non dice affatto di riferirsi agli antichi scrittori pitagorici, e può darsi benissimo, dato che la spiegazione non si ritrova nella letteratura pitagorica, che egli l’abbia attinta da quei gruppi di pitagorici romani che in quei tempi o poco dopo compaiono attorno a Nigidio Figulo, o dai predecessori di quelli che componevano in numero di 28 la confraternita pitagorica che si radunava nella basilica pitagorica sotterranea presso la Porta Maggiore. Il 28 è un numero perfetto anche nell’accezione moderna della parola, derivata pari pari da quella antica, cioè il 28 è un numero che è uguale alla somma dei suoi divisori escluso il numero stesso. Vi è però un’altra ragione che fa del 28 un numero perfetto, prendendo la parola perfezione nel senso greco etimologico della parola, che è poi anche il senso della perfezione secondo Pitagora, Aristotele e Dante, ossia di compiutezza. Esso è perfetto come lo sono il 4 e il 10: il quattro è il primo numero dopo la triade dei primi tre numeri, il 10 è il primo numero dopo le prime tre terne di numeri (ed anche perché nel sistema di numerazione decimale è la prima unità di ordine superiore e perché è legato e identificato al 4 nella relazione della tetractis: 1 + 2 + 3 + 4 = 10), ed il 28 è il primo numero che segue la terna delle tre enneadi; inoltre il suo pitmene, resto della divisione per 9, è l’unità.
Il Carcopino nel suo libro sopra la basilica pitagorica di Porta Maggiore (cfr. Jérôme Carcopino, La basilique pytagoricienne de la Porte Majeure, Paris, 1927, p. 255) mostra come i componenti la confraternita pitagorica cui la basilica apparteneva erano in numero di 28, basandosi sopra l’osservazione già fatta dalla signora Strong (Mrs. Eugénie Strong, The stuccoes of the underground basilica near the Porta Maggiore, nel Journal of hellenic studies, XLIV, 1924 pp. 65-111) che gli stucchi funerari della cella della basilica erano appunto 28.
Il Carcopino osserva che questo numero di 28 pitagorici coincide col numero dei pitagorici che, secondo il dialogo tra Policrate e Pitagora conservato sotto il nome dell’epigrammatista Socrate dall’Antologia Palatina (Antol. Pal., XIV, 1), costituivano la scuola stessa di Pitagora. In questo dialogo, infatti, Policrate domanda a Pitagora quanti atleti stia conducendo nella sua casa verso la saggezza; e Pitagora risponde: «Te lo dirò, Policrate. La metà studia l’ammirabile scienza delle matematiche, l’eterna natura è oggetto degli studi di un quarto, la settima parte si esercita alla meditazione e al silenzio, vi sono in più tre donne di cui Teano è la più distinta. Ecco il numero dei miei allievi che sono anche quelli delle muse». La radice di questa equazione di primo grado è il numero 28, ed il modo come il problema è enunciato mostra che a Pitagora interessava far vedere che esso è un numero perfetto.
A noi interessa constatare che, secondo questa dichiarazione attribuita allo stesso Pitagora, una parte dei discepoli si esercitava nelle pratiche della meditazione. Per questi discepoli il precetto dell’astensione dalle fave era quanto mai opportuno per non turbare la tranquillità dell’anima, e siccome l’interdizione era in tal modo connessa con la parte più gelosa dell’attività esoterica della scuola, già per sé stessa famosa per la sua misteriosità, era naturale che la ragione del divieto dovesse rimanere avvolta nel mistero, sebbene non sia provato che le false spiegazioni addotte ad uso dei profani risalgano proprio allo stesso Pitagora. E d’altra parte l’uso delle fave come nutrimento poteva benissimo essere consentito a coloro che non si esercitavano nella meditazione, come asserisce Aristosseno.
La spinosa questione delle fave resta così completamente risolta.
- Articolo tratto dalla Rivista di Studî Iniziatici (mondo occulto) di Napoli (Anno XXII, n. 4-5-6 della 1ª serie e n. 1 della seconda serie, Luglio-Dicembre 1948, pp. 36-41; Anno XXIII, n. 4-5-6, Luglio-Dicembre 1949, pp. 43-46; Anno XXIV, n. 1-2-3, Gennaio-Giugno 1950, pp. 41-45.