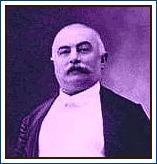“Il vegetarianesimo – aggiunge- è una forma di boicottaggio…” nei confronti di quanti traggono profitto dall’indiscriminato sfruttamento industriale delle bestie, dall’impiego su larga scala dei metodi intensivi di allevamento, e dalla commercializzazione di carcasse e cadaveri sezionati, da predisporre alla soddisfazione dei futili desideri del palato. “Per rendere più efficace l’aspetto del boicottaggio del vegetarianesimo, non dobbiamo essere schivi sul nostro rifiuto di mangiar carne. Ai vegetariani nelle società onnivore si chiede sempre la ragione della loro strana dieta. Ciò può essere irritante, o addirittura imbarazzante, ma dà anche l’opportunità di informare la gente di crudeltà di cui può non essere consapevole” (Peter Singer). Tale forma di boicottaggio non sarà ovviamente in grado di riportare in vita l’animale già macellato, ma farà riflettere sul futuro di quelle condizioni che ci appariranno subito inaccettabili quanto la complicità o la responsabilità indiretta nel perpetuarsi di omicidi e stragi.
Il vegetarianesimo è però anche una forma di utopia, perché, qualora il boicottaggio di pochi non avrà sortito alcun effetto, si sarà pur sempre seminato un ideale contrario all’oppressione, all’ingiustizia, alla crudeltà. In ogni caso avremo ottenuto, sia pur ad un ridotto livello personale, la riconoscenza di tutti quegli esseri la cui sofferenza sarà stata risparmiata dalla nostra dieta, in accordo a quel medesimo brillante spirito con cui George Bernard Shaw avrebbe invitato al proprio funerale tutto il corteo di vitelli, pecore, maiali, conigli, tacchini, polli, e pesci che non aveva mangiato in vita.
I vegetariani restano comunque consapevoli che il loro piccolo, individuale contributo non violento a tavola potrebbe, anche se in minima parte, ridurre la sofferenza futura, nella ferma convinzione che la fine della crudeltà non potrà che costituire il più ragionevole ed auspicabile dei progressi di civiltà in ogni campo dell’esistenza.
A valutare la cosa da un punto di vista strettamente economico, “… il cibo sprecato dalla produzione animale nei paesi ricchi sarebbe sufficiente, se adeguatamente distribuito, a porre fine tanto alla fame quanto alla malnutrizione in tutto il mondo” (Peter Singer), per via degli elevati costi in termini di mangimi, di energia, di acqua. Ed a questo calcolo c’è da aggiungere l’impoverimento ecologico determinato dal disboscamento necessario a creare nuovi pascoli per incrementare l’allevamento di ovini e bovini, che però, dobbiamo ricordare, non sono le sole bestie a venire sacrificate.
C’è poi da prendere in considerazione come una sorta di pseudo-preoccupazione di specie: “A che punto della scala evolutiva dobbiamo giungere? – si preoccupa Peter Singer in “Liberazione Animale” - Mangeremo il pesce o no? Che dire dei gamberetti? E delle ostriche? Per rispondere a queste domande dobbiamo tener presente il principio fondamentale su cui si basa la nostra considerazione per gli altri esseri… il solo confine legittimo per la nostra preoccupazione per gli interessi degli altri esseri è il punto in cui non è più esatto dire che un essere ha degli interessi. Per avere interessi, in senso stretto e non metaforico, un essere dev’essere in grado di soffrire o provare piacere. Se un essere soffre, non vi può essere alcuna giustificazione morale per trascurare tale sofferenza, o per rifiutarsi di valutarla quanto l’analoga sofferenza di qualsiasi altro essere. Ma anche l’inverso è vero. Se un essere non è capace di soffrire, o di godere, non c’è niente da prendere in considerazione. Perciò il problema di tracciare la linea è il problema di decidere quando siamo giustificati a ritenere che un essere sia incapace di soffrire”.
Sol perché i pesci non sono in grado di emettere gemiti e lamenti, non significa che le spasmodiche vibrazioni del loro guizzare non corrispondano alle manifestazioni dolorose espresse dai mammiferi con vocalizzazioni percepibili dalle nostre orecchie. Quanto vale per i pesci va esteso ad altre forme di vita acquatica. I crostacei, ad esempio, possiedono sistemi nervosi, sebbene diversi dal nostro, altamente sviluppati, e complessi, dalle energiche ed immediate reazioni agli stimoli esterni. I molluschi sono indubbiamente organismi più semplici. Eppure anche il polpo è un mollusco, il più sviluppato fra tutti, e dà prova di sensibilità ed intelligenza comportamentale. Allora, “… così come non si può affermare con alcuna sicurezza che queste creature siano sensibili al dolore, non si può neppure essere sicuri che non lo siano” (Peter Singer).
Arrivati al termine della scala evolutiva, andranno inclusi quei prodotti, come il latte, il miele, le uova, lo yogurt, i formaggi, che tradizionalmente rientrano in una dieta, per altro, non cruenta? L’astensione dall’uccisione dovrebbe essere sufficiente a rendere accettabile questi alimenti, che potrebbero però essere considerati, in un’ottica più restrittiva, frutto di un circuito a cui non è estranea una qualche forma di sfruttamento, e quindi di sofferenza. Verrebbero così invalidate tutte quelle disquisizioni su certe rilevanti questioni filosofiche che complicano la pratica vegetariana, perché riguardanti essenzialmente annotazioni terminologiche tali da distinguere, da un punto di vista linguistico od etimologico, quanti si limitano ad una alimentazione non violenta, accettando i prodotti animali, da quanti (vegan) invece ritengono ciò moralmente ingiustificabile, poiché le specie sfruttate non avrebbero granché da guadagnare dalla rinuncia alla carne se questa viene sostituita con un’accresciuta quantità di derivati animali, quali uova e latticini freschi o stagionati.
Sono queste le problematiche che si presentano a chi nevroticamente si pone delle domande sui rapporti tra etica e alimentazione, anche se c’è sempre un divario tra le convinzioni intellettuali e le azioni di rottura su consolidate abitudini, fino alla proposizione di nuovi stili di vita.
Le ragioni a favore di una cucina non cruenta sembrano determinate più dalla consapevolezza che il suo genuino sapore e le sue capacità nutritive vengano direttamente mutuate dalla terra, scevre da sprechi di produzione e senza la spocchiosa pretesa di essere autorizzate a macellare alcun essere vivente per via della superiorità di specie.
“Il vegetarianesimo porta con sé un nuovo rapporto con il cibo, le piante e la natura” (Peter Singer).
L’esclusione della carne e dei prodotti della morte e della putrefazione ci riporta a più stretto contatto con il tempo e le stagioni, lo spazio ed il suolo, in uno con la vita e la sua forza intrinseca.
Ed è difatti assolutamente infondata la preoccupazione di rischiare di non nutrirsi in maniera adeguata nell’abbandonare l’alimentazione onnivora, come quella di perdere alcuni piaceri irrinunciabili. La gastronomia e l’arte culinaria sono in grado di smentire queste superficiali affermazioni. E addirittura le diete che si prefiggono la salute e la longevità, quali la McDougall o la Pritikin, sono in ultima analisi ed in gran parte vegetariane. Stesso discorso vale per quanto riguarda il muesli, sfruttato a scopo sanitario da Bircher-Benner, o l’introduzione dei cereali nella prima colazione da parte di John Harvey Kellogg, autore di “Shall We Slay to Eat?” (1905).
A cominciare da Linneo (1707-1778), che stabilì l’appartenenza allo stesso ordine antropomorfo, definito poi dei Primati, sia degli esseri umani sia delle scimmie, sono molti i medici a promuovere la dieta vegetariana a scopo profilattico e terapeutico. Edward Tyson (1650-1708) dimostra la continuità anatomica tra scimmia ed uomo, il cui apparato digerente è predisposto per i cibi di origine vegetale. Agli inizi del settecento, Louis Lémery (1677-1743), con il “Traité des Aliments” (1702), cerca delle dimostrazioni con prove empiriche. Philippe Hecquet (1661-1737), pur mantenendosi nell’alveo della teologia cattolica (“Médecine théologique”, 1733), propugnava un regime “quaresimale” con il suo “Traité de dispenses de Carême” (1709).
Profilassi e cura mediante i cibi ricevettero maggior attenzione da parte del medico della famiglia reale inglese, John Arburthnot (1667-1735), autore di un “Essay Concerning the Nature of Aliments” (1730). George Cheyne (1671–1743) si specializzò nel trattamento dei disturbi nervosi per mezzo della dieta. Avidità di cibo e ghiottonerie era vista come un peccato contro natura nell’”Essay of Health and Long Life” (1724), che riscosse un notevole successo presso il pubblico femminile, soprattutto in quanto Cheyne presentava i disturbi psicosomatici, definiti “English malady”, quali sicuri sintomi di una superiore sensibilità. Ed a questo argomento faceva appello nel ricongiungerlo alla questione della compassione verso le creature viventi.
Antonio Cocchi (1695-1758), dopo un soggiorno inglese, durante il quale fu iniziato alla massoneria, lesse, in occasione del suo ingresso all’Accademia della Crusca, un discorso destinato a suscitare un ampio e vivace dibattito nella cerchia dei medici italiani dell’epoca: “Del Vitto pitagorico per uso della Medicina”(1743). In esso Cocchi definiva la dieta latto-vegetariana in grado di “guardare la presente sanità del corpo e di ristabilire la perduta”, non trattandosi soltanto di un problema di “temperanza” ma di “materie del cibo”, ovverossia di principi nutritivi. Nello specifico, gli alimenti di origine vegetale curano meglio dei farmaci, non soltanto i disturbi nervosi, ma anche gotta, reumatismi, elefantiasi e scorbuto, di cui individuava precisamente la causa nella carenza di frutta e verdura fresche. In una prospettiva epidemiologica, spiegava la frequenza di determinate malattie nelle diverse regioni, oltre che per le caratteristiche del clima, pure per i differenti stili di vita. Per lui, comunque, il vitto pitagorico non rappresentava affatto una rinuncia, anzi non lo riteneva “privo nemmeno di una certa delicata voluttà, e d’un lusso gentile, e splendido ancora, se si voglia volger la curiosità, e l’arte, alla scelta, ed all’abbondanza degli ottimi alimenti, freschi vegetabili, come pare, che c’inviti la fertilità, e naturale disposizione delle nostre belle campagne”. All’apologia di Pitagora, Cocchi affianca il primato culturale della nostra penisola, inserendo l’antica sapienza italica nel dibattito dell’epoca che allude alla critica radicale della religione quale strumento di controllo sul popolo.
Le principali raccomandazioni nutrizionali essenzialmente si riassumono, per lo più, in un invito a ridurre il consumo dei grassi saturi e del colesterolo (leggasi carne, panna e burro), aumentando l’apporto di cereali integrali, verdure e frutta. Il pregiudizio proteico trascura il dato, allarmante nei paesi ricchi dell’occidente, di un eccesso di aminoacidi da non accumulare, poiché naturalmente espulso o trasformato in carboidrati. E’, poi, senz’altro irrilevante la provenienza delle unità proteiche essenziali, purché ne venga rispettata l’adeguata mescolanza in forma assimilabile. Ricorrendo contemporaneamente a tipi diversi di alimenti di origine vegetale, quali ad esempio cereali e legumi, non è affatto difficile combinare delle perfette equivalenze a quelli che vengono considerati i valori nutritivi più elevati, secondo il principio della complementarietà proteica. Perfino la vitamina B12, infine, ritenuta non assimilabile da fonti vegetali, viene prodotta nel nostro stesso intestino da parte di microrganismi ospiti della flora batterica, ed in ogni caso si può ricavare da alghe, come la laminaria o dalla soja sottoposta a fermentazione, com’è d’uso in estremo oriente (tempeh), o dalle salse di tradizione giapponese (tamari).
In molti contesti del pensiero umano, come nel buddismo o nell’ebraismo, si reputa l’etica ben più importante della religione, e il rispetto della giustizia, di norme comportamentali e di osservanze morali un valore che aiuta a metterci in relazione con il divino in misura sicuramente maggiore della superficiale ritualità. Solo chi riesce a non rinunciare al proprio diritto alla libertà della dignità e della virtù, si distingue dalla generale uguaglianza di fronte all’in-omologabile, perché ineffabile, e può aspirare al concetto di santità. Una tale coerenza, perseguita pure nell’alimentazione, suggerisce modalità di comportamento, e di preparazione all’atto, che contribuiscono ad intessere delle solide relazioni con noi stessi. Un uomo onesto, pio, giusto, (khassidim) per gli ebrei osservanti, sarà, secondo l’espressione yiddish, “a kushere yid”. Allora il concetto di buon comportamento, di kasheruth, o di etica alimentare, per continuare a seguire sempre lo stesso esempio relativo agli israeliti, propone delle adeguatezze, dei cibi consoni, suddividendoli in permessi ed in proibiti. E il più perentorio divieto riguarda l’assoluta proibizione di alimentarsi del sangue. Ma è facile riconoscere in questo divieto una primitiva costumanza vegetariana, in certo qual modo, rimossa. Il sangue è visto cioè come un surrogato, simbolo di sacralità, perché fonte della vita. Allora il procedimento per rendere kasher la carne consiste nel farle perdere ogni traccia di linfa, lavandola e sciacquandola con acqua salata, come il mare, altra icona dell’origine dell’esistenza.
La narrazione biblica, però, ci ricorda che in principio il permesso divino consentiva di cibarsi esclusivamente di prodotti vegetali, fatta eccezione per un solo frutto emblematico per l’evoluzione esoterica della consapevolezza e della conoscenza. Dopo Caino, ma ancor più in seguito al diluvio, appare la realistica considerazione che la ferocia umana nei confronti dei propri simili non potrà, di conseguenza, risparmiare le altre specie. Cosicché la decadenza dei valori morali avrebbe ridotto il divieto alla regola esposta in Esodo (23,19): “Non cucinerai il vitello nel latte di sua madre”.
Genesi (32,33) propone poi l’interdizione per “il nervo della vena della coscia”, senz’altro bizzarra se non fosse stato proprio quello il punto anatomico in cui venne colpito Giacobbe nel corso della sua lotta con l’angelo del Signore; fu quel fatidico colpo a renderlo claudicante e quindi, simbolicamente, in continua oscillazione tra cielo e terra.
Eppure, tra i patti divini stipulati con Noè, venne subito evidenziata la proibizione di tormentare le bestie. Ragion per cui lo shokhet, che opera la macellazione rituale, quasi sulle orme dell’ ‘aqedah (il “sacrificio di Isacco”), si preoccupa di rescindere la giugulare con un’affilatissima lama, nella convinzione che questo sia il metodo meno doloroso, forse per il carnefice, più che per la vittima.
Come il tabù per il sangue, anche quello per il latte rivela la finalità di evitare la contaminazione di ciò che ha il compito di trasmettere la vita e di nutrire i primi giorni dei mammiferi con il prodotto della negazione della vita stessa. I riferimenti allo zoccolo fesso ed ai ruminanti farebbero riferimento, il primo, alla materialità, all’adesione totale alla terra, ed i secondi invece al “ritorno” del cibo per un ulteriore arricchimento nutritivo.
Il maiale aderisce fin troppo alla terra e si strafoga, e assumerlo quindi, per assomigliargli, sarebbe quanto mai sconveniente.
Sembra quasi di sentire un’eco di quell’operetta morale di Plutarco (“Gryllos”), in cui lo scrittore greco del I sec. d. C. fa dialogare con Ulisse uno di quegli uomini tramutati dalla maga Circe. Alla proposta dell’eroe di liberarlo dall’incantesimo, gli viene risposto come non sia del tutto scontato voler ritornare alla condizione precedente, poiché l’anima nella quale la virtù si accresce “spontaneamente” risulta migliore di quella “costretta” ad esprimerla. La condizione del maiale è dunque più felice dell’umana per via di una perfezione che gli è propria, mentre il ritorno all’umanità farebbe gravare sull’anima lo sforzo di perseguire una nobiltà tutta da conquistare.
Per la Mannucci (“La Cena di Pitagora – storia del vegetarianismo dall’antica Grecia a Internet”, Carocci, Roma 2008), questo breve testo di Plutarco sarebbe “in polemica con le posizioni che fondano la superiorità dell’uomo attribuendo a lui solo la sensibilità e l’intelligenza e rendendo nel contempo equivalenti tra loro e per così dire anonimi tutti gli animali”.
In appendice al dialogo di Plutarco, una novella “Circe” ripropone l’imbarazzante problema in termini psicologici. “L’antropomorfismo è un rischio che dobbiamo correre, perché dobbiamo fare riferimento alla nostra esperienza umana per formulare domande relative all’esperienza animale… – scrive Emanuela Cenami Spada in “Amorphism, mechanomorphism, and anthropomorphism”, in Robert W. Mitchell, Nicholas S. Thompson, H. Lyn Miles (a cura di): “Anthropomorphism, Anecdotes, and Animals” (Suny Press, Albany 1997) – il solo ‘rimedio’ possibile è la critica continua alle definizioni con cui operiamo al fine di ottenere risposte adeguate alle nostre domande e all’imbarazzante problema che gli animali costituiscono per noi”. Le risponde Jonathan Safran Foer, in “Se niente importa, perché mangiamo gli animali?” (Guanda, Parma 2010): “noi non ci limitiamo a proiettare l’esperienza umana sugli animali; noi siamo (e non siamo) animali”.
Chiedersi “che cos’è un animale?” è come chiedersi “chi siamo?”, non solletica solo la nostra immaginazione, equivale a separarsi dagli “altri”, ma anche a chiedersi “cos’è un essere umano?”. La nostra interazione con gli “altri” e con gli animali riflette la comprensione che abbiamo di noi stessi; la compassione e la sensibilità verso il benessere altrui contribuisce a plasmare tale comprensione e fortificarla. Nelle nostre idee circa l’alterità e l’animalità ricorre una componente emotiva fortissima, per cui sottoporle ad una stretta critica razionale rischia di svelare quegli aspetti ampiamente inesplorati dell’accezione medesima che noi abbiamo della nostra stessa umanità.
E’ un implicito richiamo alla virtù della temperanza? La suggestione del comune buon senso induce sempre all’equilibrio ed alla moderazione. Da moderare il desiderio proveniente da incontrollabili passioni, per conformarsi alla potenza di quell’azione regolatrice e mediatrice che un sano appetito suggerisce. Era questo l’autorevole pensiero di Spinoza, sul quale avrebbe potuto concordare persino Epicuro quando affermava che vanno soddisfatti solo i piaceri necessari. E la necessità si vede dettata dalla corrispondenza alla verità, ed a legittimare il piacere è l’idea, l’essenza, la sua stessa sostanza, in uno l’esistenza. Così sono i piaceri “naturali”, finalizzati alla sussistenza, e non effimeri, o superflui, anacronisticamente voluttuari, a catalogarsi come “mero supplemento”.
Molti filosofi dell’antichità classica avrebbero proiettato sull’atto di nutrirsi quello che si potrebbe definire come un vero e proprio orizzonte di “senso”, un qualcosa comunque da ricollegare strettamente al funzionamento fisiologico ed alla meccanica intestinale.
Sulla scia della moderazione e della temperanza nelle attitudini umane, alla misura nel bere e nel mangiare, qualcuno avrebbe accostato un dosaggio di tipo farmacologico. Tommaso Campanella concepiva l’alimentazione in chiave terapeutica, convinto che cibi e bevande servano non solo come nutrimento ma anche come cura.
Ma la scuola filosofica maggiormente coinvolta in quest’ambito, tanto da aver contrassegnato con il proprio nome un certo “vitto”, è quella di Crotone, la cui peculiare dieta ci descrive Giamblico. Pitagora propugnava di non arrecare alcun danno agli animali, se non per legittima necessità di difesa. La proibizione era sollecitata da una disposizione “orfica” a sintonizzarsi con il divino, inteso nella sua qualità di permeare di sé il cosmo intero.
L’atto di mangiare nell’uomo non risulta essere una semplice funzione né fisiologica né meccanica. L’umanità si distingue dal mondo animale anche per questo, per il modo in cui si ciba. E la sua essenza specifica potrà rintracciarsi nella modalità di alimentarsi e forse anche e soprattutto in “cosa” mangia. Nel non ripetersi e nel variare sta in parte una caratteristica distinzione della logica e del raziocinio tipicamente umani. All’interno di una medesima specie animale l’atto di cibarsi è sempre uguale, prevedibile nella sua monotonia, non contraddistinto se non dalla sua stessa caratterizzazione di specie.
Se per Aristotele l’uomo è un animale dotato di logos, va anche ammesso che tale affermazione scaturisce proprio dallo stesso logos, che ne riconosce l’originaria animalità. Insomma la natura umana è duplice, ma non corrisponde affatto alla semplice somma delle parti. Sta forse in questo una qualche verità sul più intimo segreto della questione dibattuta circa la reale essenza dell’umanità.
Tutti gli esseri viventi si nutrono, ma l’atto di mangiare è proprio degli animali, anche se certe piante tropicali sembrano fare eccezione. L’ambiguità di questo assioma potrebbe caratterizzare la natura umana sia nel senso di accomunarla che in quello distinguerla da quella degli altri animali, per la qual cosa alla prima si addice il verbo tedesco essen (consumare) ed agli altri: fressen (divorare).
Qualcuno si è spinto a sostenere che non sia la coscienza, il pensiero, il linguaggio, o la spiritualità, a contraddistinguere il genere umano, bensì ciò che ingerisce.
Jakob Moleschott (1822-1893), con “Der Kreislauf des Lebens” (1852), aveva interpretato l’alimentazione come un qualcosa che avrebbe contribuito al costituirsi ed al perfezionarsi della cultura, individuando un certo parallelismo tra il miglioramento del nutrimento ed il progresso della civiltà (“Niente fosforo, niente pensiero”). Ludwig Andreas Feuerbach (1804-1872), con il suo celebre saggio del 1862, “Il mistero del sacrificio o l’uomo è ciò che mangia”, ricercava sotto una nuova prospettiva l’unità inscindibile tra psiche e corpo. Ne scaturiva l’esplicito invito a scegliere con maggiore attenzione il proprio cibo, perché così facendo si sarebbe potuta sperimentare una più raffinata attitudine al pensare ed all’agire, contribuendo insomma a fornire un’utile, quanto semplice, impulso alla naturale evoluzione interiore dei singoli e conseguentemente dell’umanità intera.
Giuseppe M. S. IERACE
Bibliografia essenziale:
Alliata di Salaparuta E.: ”Cucina vegetariana e naturismo crudo”, Sellerio, Palermo, 1973
Baroni L.: “VegPyramid, la dieta vegetariana degli italiani”, Sonda, Casale Monferrato 2008
Foer J. S.: “Se niente importa, perché mangiamo gli animali?”, Guanda, Parma 2010
Ierace G.M.S.: “Yoga e Alimentazione”, su Yoga per una rinascita universale, pag 8-10, I, 1, gennaio marzo 1980
,, ,, “Contro la Caccia”, su Yoga per una rinascita universale, pag 30-32, I, 2-3, aprile settembre 1980
,, ,, “Agricoltura naturale alimentazione salutare”, su Yoga p. u. r. u., pag 37-39, III, 7, gennaio aprile 1982
,, ,, Presentazione a “Lo Yoga del Nutrimento” di Jack Santa Maria, Siad, Milano, 1983
,, ,, “Yoga e Alimentazione”, su Yoga & Ayurveda, pag 19-25, n° 21, marzo 1987
,, ,, “Esoterismo e dieta alimentare”, su Riv. It. di Teosofia, pag 21-25, XLV, 1, gennaio 1989
,, ,, Prefazione e Appendici a “Perchè Vegetariani” di Kath Clements, (Ecologia Pratica 5), red, Como, 1991
,, ,, “Storia naturale e morale dell’alimentazione”, su Riv. It. di Teosofia, pag 308-11, XLVIII, 11, nov. 1992
,, ,, “Alla scoperta del pensiero animale”, su Riv. It. di Teosofia, pag 78-84, XLIX, 3, marzo 1993
,, ,, “Il colore del cibo”, su “Calabria Sconosciuta”, pag. 15-20, XXIII, 88, ott.-dic. 2000
,, ,, “Pietà verso gli Animali”, su Sixtrum, pag 15-17, II, 1, 2001
,, ,, “L’inquietudine nel piatto, ovvero dell’ortoressia”, www.nienteansia.it
,, ,, “Immedesimazione … negazione, indifferenza”, su www.nienteansia.it
,, ,, “Biofilia, dallo sguardo al tatto”, su www.nienteansia.it
,, ,, “Empatia… neuroni a specchio”, su www.nienteansia.it
L’Ecologist italiano: “Agricoltura è disegnare il cielo”, LEF, Firenze, 2007
Mabey R.: “Natura come cura”, Einaudi, Torino 2010
Mannucci E. J.: “La Cena di Pitagora – storia del vegetarianismo dall’antica Grecia a Internet”, Carocci, Roma 2008
Martinetti P.: “Pietà verso gli animali” (a cura di Di Chiara A.), Il Melangolo, Genova, 1999
Mitchell R. W., Thompson N. S., Miles H. L. (a cura di): “Anthropomorphism, Anecdotes, and Animals”, Suny Press, Albany 1997
Montanari M.: “Il Cibo come Cultura”, Laterza, Bari 2004
Masson J. M.: “Chi c’è nel tuo piatto? Tutta la verità su quello che mangi”, Cairo, Milano 2009
Olivares M.: ”Vegetariani, come dove, perché”, Malatempora, Roma, 2002
Piterà F., Cappello L. e Taglietto M.: “Il Segreto dei Cibi”, Nova Scripta, Genova 2009
Plutarco: “Del mangiar carne”, Adelphi, Milano, 2001
Precht R. D.: “Ma io, chi sono? (ed eventualmente, quanti sono?)”, Garzanti, Milano 2009
Rosen S.: “Il Vegetarismo e le Religioni del mondo”, Gruppo Futura, Jackson Libri, Bresso, 1995
Scaletti F. J.: ”Dalla parte del cappone”, Lalli, Poggibonsi, 1990
Singer P. : “Liberazione Animale”, Net, Milano 2003
Voltaire (F.M.A.): “La cena del conte di Boulainvilliers”, Editori Riuniti, Roma, 1984
Zanga G.: ”Filosofia del vegetarianesimo”, Bresci, Torino, 1987
Tratto da ELIXIR n° 10, con il permesso delle Edizioni Rebis.